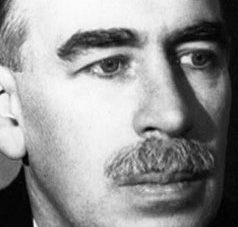 DI GUIDO FERRO CANALE*
DI GUIDO FERRO CANALE*
L’età di Keynes e di Bretton Woods (1944-1971)
La Seconda Guerra Mondiale sovverte completamente lo scenario geopolitico, offrendo agli Stati Uniti – che emergono come potenza egemone rispetto ad un’Europa in rovina – l’opportunità di progettare un nuovo ordine (economico) mondiale, volto ad eliminare i tre grandi mali del periodo interbellico: volatilità dei cambi, barriere doganali[1] (e nazionalismo economico in genere), squilibri eccessivi nella bilancia dei pagamenti. I rappresentanti delle Nazioni Unite [2], riuniti a Bretton Woods, vedono un solo mezzo adatto ad evitarli: la cooperazione internazionale, affidata al governo di istituzioni create ad hoc. Nascono, così, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Al primo compete la gestione del nuovo gold exchange standard, quindi delle parità che ciascuno Stato membro manterrà con il dollaro, che, rimasto unica valuta convertibile in oro [3], si avvia a diventare la moneta del mondo interno, la “liquidità internazionale” per antonomasia) [4]; inoltre, per ovviare a squilibri temporanei nella bilancia dei pagamenti, gli Stati medesimi potranno attingere alle riserve del Fondo, autorizzato a concedere prestiti a breve termine (per un massimo di tre anni) [5]. Gli interventi strutturali spettano, invece, alla Banca mondiale [6]; e in tale sede, «perfino negli anni in cui imperava l’ideologia del libero mercato [sic!], spesso si discuteva di quali potessero essere le politiche più idonee per risolvere i problemi di un determinato paese» [7].
La stessa esistenza di due istituzioni pone un problema di rapporti reciproci; e, dopo un iniziale riparto di compiti [8], si instaura, nella prassi, una netta supremazia del Fondo [9].
Invece, la promozione del libero scambio, obiettivo condiviso dalle Nazioni Unite, dovrebbe spettare ad una terza istituzione, l’Organizzazione Internazionale del Commercio (ITO); ma l’accordo istitutivo[10] non ottiene la ratifica del Congresso degli Stati Uniti, timoroso di perdere la sovranità sulla politica commerciale, sicché si deve prorogare l’accordo-ponte – il GATT, General Agreement on Tariffs and Trade[11] – raggiunto per ottenere i primi risultati concreti, in vista del varo della nuova organizzazione. Perciò, i progressi del libero scambio, negli anni e decenni successivi, sono scanditi dalle tornate negoziali che conducono a modifiche del GATT [12]: così prende il via un aspetto fondamentale della globalizzazione. Ma solo il 1 Gennaio 1995 entrerà in funzione il nuovo ente preposto al suo governo, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) [13].
Invece, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) riveste, fin dall’inizio (1948), un ruolo marginale: la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in quel momento, non è sentita come un problema [14]; l’uniformità del loro trattamento giuridico, pur avvertita come ideale (e utile strumento per prevenire forme di dumping sociale, o concorrenza al ribasso sui diritti), resta impercorribile, data la spaccatura del mondo in due blocchi. Così, mentre un numero via via crescente di Paesi sperimenta il collettivismo di impronta sovietica, il Primo Mondo conosce decenni di prosperità crescente, in cui si afferma un modello sociale ben preciso, che può definirsi “fordista-keynesiano” [15]: “fordista” non tanto per l’impiego su vasta scala della catena di montaggio, o del taylorismo come metodo di divisione del lavoro, ma per «la sua visione, il suo esplicito riconoscimento del fatto che produzione in serie significasse consumo di massa», “keynesiano” perché «Doveva essere ideato un nuovo modo di regolazione per soddisfare le esigenze della produzione fordista […]. La crisi era vista fondamentalmente come assenza di domanda effettiva di prodotti» [16].
Il sistema viene, quindi, a reggersi su un «rapporto di forze, teso ma tuttavia saldo, fra la forza lavoro organizzata, il capitale delle grandi aziende e lo stato nazionale», in cui i sindacati ottengono il riconoscimento di un certo potere, che consiste nello «scambiare aumenti salariali reali con la cooperazione nell’indurre i lavoratori ad accettare il sistema produttivo fordista» [17]; le grandi imprese assicurano un regolare incremento degli investimenti (quindi di domanda e produttività), votandosi alla pianificazione “scientifica” e generale, anche nel marketing; lo Stato mantiene, a sua volta, stabile la domanda – presupposta dagli investimenti – tramite politiche anticicliche, agevola in vario modo il raggiungimento degli accordi salariali e assicura “benessere sociale” tramite una serie di servizi (Welfare State nell’accezione più ampia).
«Il fordismo postbellico deve essere visto, quindi, non tanto come un semplice sistema di produzione in serie quanto come uno stile di vita» [18], dove la standardizzazione di prodotti ed esistenza si presta, certo, alla denunzia beffarda della Pop Art, ma, d’altro canto, ciascuno può ottenere una buona dose di stabilità e certezze: ogni lavoratore conosce le proprie mansioni, sa che resteranno, pressapoco, le stesse per tutta la sua carriera (salvi gli effetti, comunque prevedibili, delle promozioni) [19]; può contare su una data certa per il pensionamento e attendersi una buona qualità della vita per la vecchiaia… per non parlare del fatto che, non appena un contratto di lavoro è siglato, entrambe le parti sono consapevoli che – al netto di eventi del tutto eccezionali – si è instaurato un rapporto che durerà per tutta la vita lavorativa del dipendente. Insomma, la contropartita è tale da assicurare al sistema un ampio consenso sociale (pur non unanime) [20].
Questo è tuttora l’orizzonte mentale in cui si muovono partiti politici e opinione pubblica dell’Occidente: il paradigma culturale è sopravvissuto di una generazione almeno al tramonto della realtà economica corrispondente.
Tramonto, peraltro, inevitabile. «Il lungo boom del dopoguerra dipendeva fondamentalmente da una massiccia espansione del commercio internazionale e dei flussi degli investimenti internazionali», in modo che sempre nuovi lavoratori e merci sempre nuove venissero attratti nel circuito dell’Occidente fordista-keynesiano. Inoltre, «la capacità di fornire beni collettivi dipendeva dalla continua accelerazione della produttività dei lavoratori nel settore delle grandi aziende. Soltanto in quel modo poteva essere fiscalmente possibile il welfare state keynesiano» [21]. E se, su questo fronte, problemi di ristagno si manifestavano già intorno alla metà degli anni Sessanta, il colpo mortale al sistema venne inferto dal crollo del regime monetario di Bretton Woods [22].
*Link all’originale: http://vonmises.it/2013/03/13/ipermodernita-la-catastrofe-economica-occidentale-leta-di-keynes-e-bretton-woods/
NOTE
[1] Il libero scambio è uno dei quattro princìpi su cui si fondano i Quattordici punti di Wilson: Attali 2011, p. 166.
[2] L’espressione designava, allora, i membri della coalizione alleata, il cui riferimento ideale era la Carta Atlantica (che contiene anche princìpi economici): l’Organizzazione delle Nazioni Unite viene fondata solo l’anno seguente, il 29 Aprile 1945. Cfr. Attali 2011, pp. 181-187.
[3] Ma solo per i saldi dei Governi stranieri, al tasso fisso di 35 dollari l’oncia fissato da Roosevelt nel 1934. V.amplius Rueff (1972), pp. 61-116.
[4] Per questo il Fondo è controllato dagli europei: questo potere di gestione del sistema è la contropartita che rende politicamente accettabile l’affermazione della supremazia statunitense nel sistema valutario.
[5] Stiglitz 2002 sostiene che il Fondo avrebbe ricevuto anche il compito di promuovere una politica internazionale di sostegno alla domanda aggregata, fungendo anche da “gruppo di pressione”, e che così l’avrebbe concepito lo stesso Keynes; ma gli scopi istituzionali del FMI si limitano – come da Statuti – alla promozione di stabilità cambiaria e commercio internazionale, gli Stati non assumono obbligo alcuno in ordine alla domanda aggregata e, soprattutto, i crediti a breve del Fondo sarebbero strutturalmente inadatti ad una politica anticiclica. Semmai, una lettura “keynesiana” del sistema di Bretton Woods porterebbe a concludere che, delle due “leve” cui l’economista di Cambridge affida la correzione degli squilibri economici, quella degli investimenti sta nelle mani della Banca mondiale e che il Fondo gestisca quella monetaria; ma con un caveat importante, perché Lord Keynes, a Bretton Woods, ha visto respinto il proprio grandioso progetto di una cartamoneta mondiale, il bancor (cfr. Attali 2011, pp. 184-185), da lui propugnata perché assai più facile a manovrarsi delle parità auree. Infine, quanto al ruolo di “gruppo di pressione”, per cui lo Statuto non gli attribuisce i mezzi, il Fondo lo ha bensì sviluppato (in via di prassi), ma, notoriamente, in favore di politiche non keynesiane.
[6] Il cui nome ufficiale, infatti, è Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Anche per questo, non appaiono condivisibili le considerazioni di Stiglitz 2002, p. 11: «Nato sul presupposto che i mercati spesso funzionino male, ora sostiene con fervore ideologico la supremazia del mercato. Costruito sul convincimento che occorre esercitare una pressione internazionale sugli stati affinché adottino politiche economiche più espansive – aumentando per esempio le spese, riducendo le imposte oppure abbassando i tassi di interesse per stimolare l’economia – oggi l’FMI tende a fornire i fondi solo ai paesi che si impegnano a condurre politiche volte a contenere il deficit, ad aumentare le tasse oppure ad alzare i tassi di interesse e che pertanto conducono ad una contrazione dell’economia.».
[7] Stiglitz 2002, p. 13. Va detto che l’A. ha lavorato a lungo presso la Banca mondiale…
[8] Poco sensato anche secondo la Teoria Generale di Keynes: le due leve debbono agire di concerto. E, in ogni caso, è indubbio che gli effetti delle politiche di intervento non possano essere circoscritti a determinati settori mediante compartimenti stagni, sicché un coordinamento tra le due istituzioni si imponeva; e, vista l’impossibilità di adottare a priori un criterio di soluzione valido per tutti i potenziali conflitti futuri, il loro esito non poteva che essere rimesso all’esame del caso concreto e, soprattutto, al gioco dei rapporti di forza. La supremazia del FMI è confermata, d’altra parte, anche da una visibilità mediatica ben superiore alla Banca mondiale.
[9] Al riguardo, scrive Stiglitz (2002), p. 13, «Inizialmente, c’era stata una divisione dei compiti. Nei rapporti con un determinato paese, l’FMI doveva limitarsi a questioni di macroeconomia, debito pubblico, politica monetaria, inflazione, deficit commerciale e debito esterno, mentre la Banca mondiale si sarebbe occupata delle questioni strutturali – in che cosa investiva il governo, le istituzioni finanziarie del paese, il mercato del lavoro, le politiche commerciali. Ma l’FMI adottò una visione piuttosto imperialistica del proprio ruolo; dal momento che quasi tutte le questioni strutturali potevano pregiudicare i risultati complessivi dell’economia e, di conseguenza, il bilancio dello Stato o il deficit commerciale, riteneva che praticamente tutto fosse di sua competenza».
[10] Noto come Carta de L’Avana, elaborata tra il 1946 e il ’47, sottoscritta da 53 Paesi il 24 Marzo 1948. La logica di fondo era la stessa di Bretton Woods: alle posizioni degli economisti classici, che propugnavano l’eliminazione pura e semplice delle barriere doganali e delle misure protezioniste in genere, si sarebbe sostituita un’istituzione ad hoc, con il compito, più modesto, di promuoverne la rimozione graduale.
[11] Siglato a Ginevra da 23 Paesi, il 30 Ottobre 1947.
[12] Lo stesso nome – p.es. Uruguay Round – designa, peraltro, sia la tornata negoziale (e deriva, in genere, dal luogo in cui essa si è aperta), sia il Trattato conclusivo. anche il frutto di tali trattative, cioè il trattato conclusivo. I primi round (Ginevra, Annecy, Torquay, 1948-51) si sono risolti in successive riduzioni delle tariffe per prodotti specifici, ma il quarto (Ginevra 1956) ha convolto anche i Paesi in via di sviluppo (la conferenza di Bandung risale all’anno precedente), definendo le strategie per la progressiva apertura dei loro mercati. Dopo un’altra tornata di riduzioni specifiche (Dillon Round, 1960-61), il salto di qualità si è avuto con il Kennedy Round (1964-67), che ha coinvolto 62 Paesi – il massimo precedente erano i 38 di Torquay – e portato alla prima riduzione generale, peraltro accompagnata da misure anti-dumping, respinte dal Congresso USA. Il successivoTokyo Round (1973-79, 102 Paesi) è passato ad occuparsi anche delle barriere non tariffarie e l’ultima tornata negoziale conclusa con successo, l’Uruguay Round (1986-94), oltre a coinvolgere i servizi e il settore della proprietà intellettuale (accordo TRIPs), ha trasformato l’organizzazione di fatto – anch’essa denominata GATT, nata per gestire i round, ma, fino ad allora, mai divenuta soggetto di diritto internazionale – nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).
[13] «La prima e unica istituzione veramente sovranazionale, almeno relativamente ai contenziosi [sul commercio internazionale]: tribunali ad hoc, allestiti dall’organo di regolamento delle vertenze, […] permettono di decidere se un paese è in buona fede quando invoca ragioni specifiche per giustificare una distorsione o una deroga alla concorrenza. Questi tribunali, realmente sovranazionali, ai quali è del resto successo di condannare gli Stati Uniti, sono essenzialmente al servizio di un libero scambio in funzione soprattutto dei paesi più forti. Inoltre, sono ancora poco efficienti: su 418 vertenze messe a registro, solo 86 sono state regolate o archiviate.». Attali 2011, pp. 231-232.
[14] Riguarda, d’altronde, soprattutto gli Stati Uniti, in qualità di beneficiari; e, per la superpotenza, gestire flussi migratori è un’abitudine consolidata.
[15] «Accetto senz’altro l’opinione secondo cui il lungo boom postbellico, dal 1945 al 1973, è stato costruito su un certo insieme di pratiche di controllo dei lavoratori, mix tecnologici, abitudini di consumo e configurazioni di potere politico-economico, e secondo cui questa configurazione può essere ragionevolmente definita fordista-keynesiana. Il venir meno di questo sistema a partire dal 1973 ha inaugurato un periodo di rapido cambiamento, di fluidità, di incertezza.». Harvey 1990, pp. 154-155.
[16] Harvey 1990, pp. 158 e 161.
[17] Harvey 1990, pp. 163 e 167-168.
[18] Harvey 1990, p. 169.
[19] Si noti che «L’etimologia del termine inglese career (“carriera”) […] rimanda a una “strada per carri”: e questa parola, applicata al lavoro, indicava in quale direzione un individuo doveva incanalare i propri sforzi in campo economico. Una direzione che era necessario seguire per tutta la vita. […] Nell’inglese del Trecento la parola job (“lavoro”) indicava un “blocco” o un “pezzo”, qualcosa che poteva essere spostato da una parte o dall’altra. Oggi la flessibilità sta riportando in auge questo significato arcaico». Sennett (1999), p. 9.
[20] «Non tutti traevano benefici dal fordismo, e vi erano abbondanti segni di scontento ance all’apogeo del sistema. In primo luogo, le trattative salariali del fordismo si limitavano a certi settori dell’economia e a certi stati nazionali dove una stabile crescita della domanda poteva essere accompagnata da investimenti su larga scala nella produzione in serie. Altri settori di produzione ad alto rischio dipendevano ancora da salari bassi e dalla precarietà del posto di lavoro. E perfino i settori fordisti potevano poggiare su una base non fordsta di subappalto.». Harvey 1990, p. 172.
[21] Harvey 1990, pp. 170 e 173-174.
[22] L’insostenibilità intrinseca di tale regime costituisce la tesi principale di Rueff (1972), che la sostiene con vigore; ma appare pacifica ad occhi Austriaci.


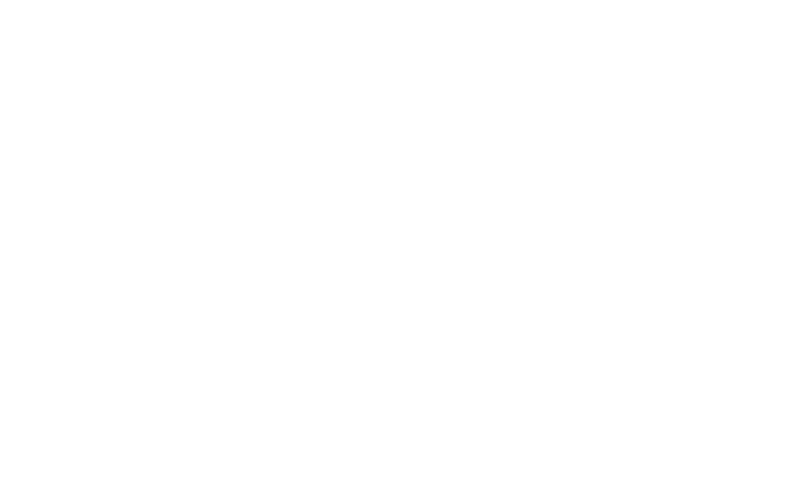
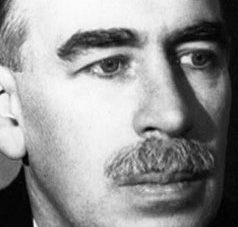

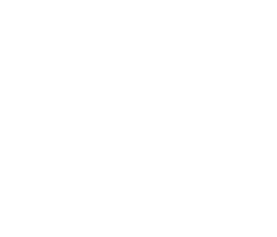
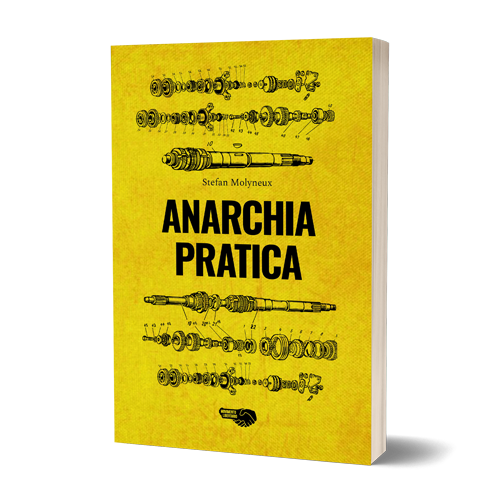



La Teoria Generale di Keynes, ridotta all’osso, sostiene due cose:
1) più quattrini incassa lo Stato, più voti potrà comprarsi con il welfare:
2) questo alla lunga distruggerà l’economia, ma non dobbiamo preoccuparci, tanto nel lungo periodo saremo tutti morti.
La verità è tutta nelle parentesi di Max. Non c’è mai stata denuncia e non c’è mai stata arte. Più che trasformata, l’azione partiva dalle origini per imbrogliare il pubblico. Un po’ come il 1968 in Europa e in Italia in particolare: realizzare profitti in nome della condanna ideologica del profitto. A questo servono le Woodstock dei pacifondai: a preparare guerre di aggressione o o comunque, se attaccati, a ostacolare le azioni diplomatiche che possono evitare il conflitto armato. Altrimenti i debiti ideologici di Keynes e quelli di giuoco di Cavour o di Emilio fede, chi li paga?
Interessante, ma credo che la denuncia beffarda (se mai c’è stata denuncia) dell’arte pop (se mai c’è stata arte) al consumismo si sia trasformata presto e volentieri in consumistico business, ovvero in consumismo tout court.