“Pensiamo sia assolutamente sbagliato in questa stagione intervenire in quel modo sui licenziamenti. Pensiamo che sia sbagliato affermare, in qualunque stagione, un potere unilaterale delle imprese sui lavoratori.” (S. Camusso)
Le discussioni sulla riforma del mercato del lavoro hanno finito, come era prevedibile, per concentrarsi sulla modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Un argomento ad alta tensione, che finora ha folgorato chiunque abbia cercato di riformare, rendendolo simile a quanto avviene in altri Paesi civili, il momento della separazione tra azienda e lavoratore dipendente. Momento difficile anche in caso di giusta causa, dato che è assai arduo convincere i giudici del lavoro della sua sussistenza. Il fatto è che nelle aziende che superano la soglia dei 15 dipendenti – quelle cioè per le quali è prevista l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 18 – il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato entra in possesso di due opzioni: una opzione “call” e una opzione “put” aventi per sottostante la propria attività lavorativa. In molti altri Paesi civili, il lavoratore dispone dell’opzione “call”, ma non della “put”.
Per chi non avesse dimestichezza con il concetto di opzione (finanziaria), vale la pena di descriverle brevemente. Si tratta del contratto che conferisce all’acquirente il diritto di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) un determinato bene (sottostante) a un determinato prezzo (strike price) a una determinata scadenza (opzione europea) o entro una determinata scadenza (opzione americana). A fronte di questo diritto, il compratore dell’opzione paga un premio al venditore. Il premio rappresenta la perdita massima nella quale può incorrere il compratore. Il venditore, per contro, a fronte dell’incasso del premio può incorrere in perdite potenzialmente illimitate, nel caso in cui (a scadenza) il prezzo del sottostante sia superiore allo strike (opzione call) o inferiore allo strike (opzione put).
Siano quindi:
C(X): (prezzo di una) opzione call
P(X): (prezzo di una) opzione put
S0: prezzo spot del sottostante
ST: prezzo del sottostante a scadenza
X: prezzo d’esercizio (strike price)
T: tempo in cui scade l’opzione
t: tempo a scadenza (T – 0)
s: volatilità del sottostante
r: tasso d’interesse
Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, in qualsiasi momento precedente la scadenza il valore di un’opzione può essere suddiviso in valore intrinseco (VI) e in valore temporale (VT). Il VI è pari al maggiore tra zero e la differenza tra il prezzo del sottostante e lo strike price nel caso di un’opzione call, mentre è pari al maggiore tra zero e la differenza tra lo strike price e il prezzo del sottostante nel caso di un’opzione put.:
VI call = max (0; S0 – X)
VI put = max (0; X – S0)
Il VT dipende sostanzialmente dalla volatilità del sottostante, dal tempo a scadenza e dal tasso di interesse, aumenta all’aumentare dei primi due, mentre un aumento del tasso di interesse determina una riduzione del valore di un’opzione call e un aumento per l’opzione put. Il VT è ovviamente pari a zero alla scadenza dell’opzione.
Alla scadenza dell’opzione, pertanto, il valore è pari a:
call = max (0; ST – X)
put = max (0; X – ST)
Dopo questa semplificata panoramica sulle opzioni, tornerei al contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e all’articolo 18.
Il dipendente, dunque, possiede due opzioni: una “call” e una “put” aventi per sottostante la propria attività lavorativa. Lo strike price è lo stipendio che percepisce a fronte della prestazione lavorativa. Per semplificare ulteriormente l’esposizione, si può supporre che non esista il cuneo fiscale, ossia che lo Stato non si intrometta tra azienda e lavoratore. Si tratta, a onor del vero, di una questione di importanza non secondaria, soprattutto considerando le dimensioni del fenomeno in Italia.
Supponendo che il costo per l’azienda corrisponda a ciò che percepisce il lavoratore, si può sostenere che il dipendente ha convenienza a esercitare l’opzione call in suo possesso (ossia a recedere dal contratto) quando il valore di mercato della propria attività lavorativa (S0) è superiore allo stipendio (X). In altra parole, cambia azienda quando, a parità di altre condizioni, può ottenere una retribuzione superiore. Il datore di lavoro può evitare il recesso del lavoratore solo adeguando (X) a (S0). Non lo farà se ritiene di poter sostituire quel dipendente con uno che lavori altrettanto bene e a un costo inferiore, oppure se adeguando lo stipendio il margine prodotto da quel lavoratore diventasse negativo per l’azienda.
Fin qui nulla di diverso da quello che succede in ogni economia di mercato.
Adesso facciamo entrare in gioco l’articolo 18 e l’opzione put in possesso del lavoratore dipendente. In questo caso, il valore dell’opzione put aumenta quanto più lo stipendio (X) è superiore al valore di mercato dell’attività lavorativa del dipendente (S0), e quanto più lontana è la scadenza dell’opzione (nel caso di un contratto a tempo indeterminato, la data del pensionamento).
Dalla semplificazione appena esposta, si deduce che l’articolo 18 tende a tutelare sostanzialmente quei lavoratori dipendenti il cui stipendio è superiore a quanto il mercato valuta la loro attività lavorativa. Ciò può avere diverse cause, ma non dovrebbe risultare blasfemo affermare che l’articolo 18 tende a tutelare chi lavora poco e male e che, di conseguenza, sono i lavativi coloro che più devono temere una sua riforma.
Né dovrebbe essere considerato un reato di lesa maestà sindacale osservare che (taluni tra) i sindacati, opponendosi a ogni riforma dell’articolo 18, tendono a tutelare maggiormente i lavativi rispetto a coloro che fanno fino in fondo il loro dovere, come previsto dal contratto.
Come se ciò non bastasse, a pagare le conseguenze delle distorsioni provocate dall’articolo 18 sono sia i dipendenti che lavorano bene, sia i disoccupati (soprattutto giovani). I primi, perché subiscono le esternalità negative dei colleghi le cui opzioni put hanno valore positivo (nel caso estremo, l’azienda potrebbe fallire, facendo perdere il lavoro a tutti quanti). I secondi, perché per loro è sempre più difficile trovare lavoro.
La riforma dell’articolo 18, se avvicinasse la disciplina italiana a quella di altri Paesi un po’ meno avversi al libero mercato, finirebbe per togliere la put ai dipendenti, dando un’opzione al datore di lavoro per recedere dal contratto pagando un indennizzo pari ad un certo numero di mensilità di stipendio (N x X). Volendo evitare di dilungarmi in dettagli tecnici, in buona sostanza il datore di lavoro avrebbe convenienza a esercitare l’opzione quando, a parità di altre condizioni, la sommatoria dei valori attuali delle probabili future differenze negative tra valore della prestazione del lavoratore e lo stipendio pagatogli fosse maggiore dell’indennizzo da riconoscergli in caso di licenziamento.
Personalmente dubito che in Italia l’articolo 18 possa essere riformato in nome del libero mercato (che ha assai pochi sostenitori nel Belpaese). Ma coloro che ritengono che la normativa dovrebbe essere caratterizzata da equità credo dovrebbero avere più di un motivo per volerlo riformare. Sul fatto che chi si oppone usi spesso il termine equità lascio ad ognuno fare le considerazioni che ritiene più opportune.
* Link all’originale: http://www.lindipendenza.com/articolo18-lavativi/




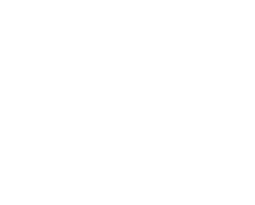
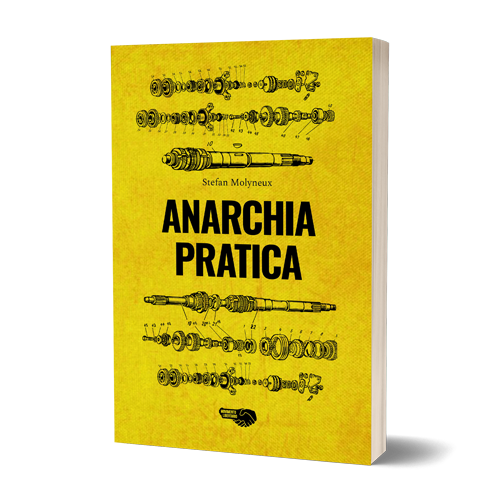

Questo punto di vista l’ho già sentito espresso in termini di produttività, nel senso che l’ingresso di lavoratori più vocati in luogo di quelli protetti dall’art. 18 dovrebbe generare un aumento della produttività del lavoro. Mi viene però da chiedere che cosa ne sarà di colore che dovessero manifestare un’inabilità assoluta. Parecchia di questa gente oggi lavora per la p.a., forse che l’art. 18 sia stato un modo per ripartirne il carico sulla collettività?
Quanti sono che hanno un’inabilità assoluta? Naturalmente pochissimi e questi potrebbero essere assorbiti da una normale assicurazione. Ovviamente non in Italia, dove gli invalidi assoluti sono in numero maggiore di quelli attivi. Poi il tutto verrebbe superato se, a mio avviso, si lasciasse libertà assoluta di contrattare alle parti. Questo significa che la legge non potrebbe imporre il contratto obbligatorio a tempo indeterminato, ma tale opzione sarebbe lasciata alle parti. Ovviamente ad un datore di lavoro non è che sia interessato a cambiare continuamente i suoi dipendenti, perchè ad ogni cambio bisogna stare ad insegnare ai nuovi il lavoro. Poi se uno è particolarmente bravo, il datore farebbe di tutto per accaparrarselo. Poi si introdurrebbe anche una responsabilità del lavoratore nei confronti del suo datore; infatti oggi il datore non può mai licenziarlo, mentre se un lavoratore, nel bel mezzo di un’importante commessa decidesse di cambiare, questo lo può fare, senza pagare niente per la chiusura anticipata del rapporto. E’ una disparità che va eliminata!!!!!