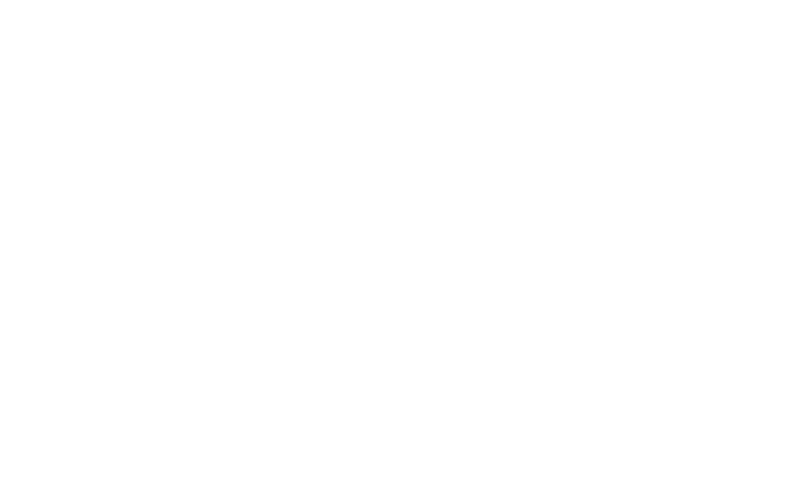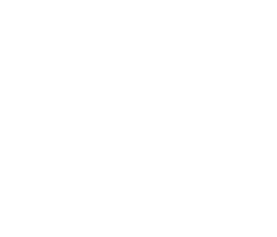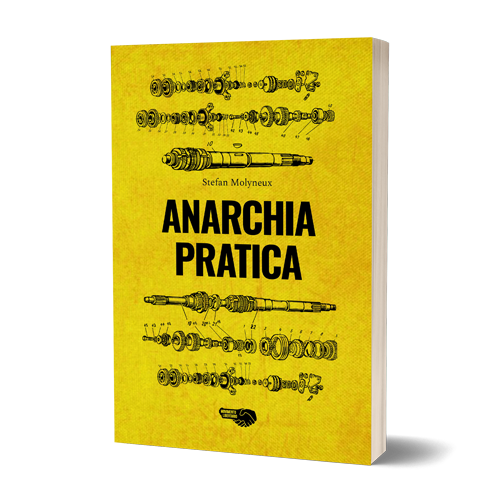di Gerardo Gaita
Un monopolio legale della violenza non può che funzionare a beneficio di coloro che ne fanno uso
La tendenza a concettualizzare lo Stato come strumento “nostro” anziché “loro”, cioè nelle mani di coloro che, possedendolo di fatto, ne fanno utilizzo a loro vantaggio, è alla radice degli sviluppi più pericolosi negli ordinamenti statali.
La logica dello Stato è, infatti, il dilagare ovunque non incontri limiti (che, una volta incontrati, cercherà comunque di superare) obbedendo a una sorta di legge di gravità, che si ritrova nelle azioni e nelle decisioni di coloro che impersonano lo Stato.
Nel perseguire la propria stringente logica di fondo, lo Stato, allo stesso tempo, fornisce beni pubblici come sottoprodotto della sua ricerca di entrate fiscali, ma fornire beni pubblici è solo un elemento accessorio rispetto al fine dello Stato, cioè la massimizzazione del proprio potere sovrano.
L’argomentazione dei beni pubblici secondo la quale l’offerta di questi beni senza l’intervento dello Stato sarebbe inadeguata, rappresenta una delle più formidabili formule di legittimazione del potere dello Stato che gli ideologi (dello Stato) siano riusciti a elaborare e a impiegare per giustificare l’ampliamento virtualmente illimitato della sfera dell’intervento statale, perché è estendibile a tutte quelle merci e a tutti quei servizi classificabili come socialmente utili.
A tutto ciò, si aggiunga che il tentativo di alcuni teorici di basare l’ordinamento statale su costituzioni a cui demandare il compito di limitare il potere dello Stato risulta essere irrimediabilmente ingenuo, dato che, in quanto intra-statali e niente affatto esterni o neutrali, i cosiddetti “checks and balances” del costituzionalismo possono fornire di per sé soltanto anemici vincoli contro l’esercizio e il meccanismo di autoaccrescimento del potere dello Stato.
Progettare costituzioni con lo scopo di fissare i confini dell’intervento statale è pertanto illusorio: le costituzioni sono, infatti, come “cinture di castità” imposte agli uomini politici, le cui chiavi però (il monopolio legale della violenza) sono sempre a portata di mano di coloro che impersonano lo Stato.
Non è una caso quindi che i tentativi liberali di limitare lo straripare del potere statale abbiano incontrato già nel Novecento un chiaro fallimento: tanto meno i limiti dello Stato sui diritti privati della libertà e del capitale vengono naturalmente stabiliti dal potere dei titolari di tali diritti, quanto più i meccanismi istituzionali che dovrebbero tutelare la comunità dall’invadenza dell’apparato statale perdono efficacia.
Di fatto, il costituzionalismo, come abito volto a limitare il potere sovrano, è servito, invece, da copertura ideologica funzionale a far accettare il vero motore dell’autoaccrescimento del potere sovrano come fine inevitabile perseguito dallo Stato, spersonalizzandone l’azione.
Di conseguenza, questo costituzionalismo fornisce sostanzialmente solo una facciata pseudo-contrattuale al monopolio legale della violenza, che nella realtà rimane una finzione giuridica volta a spersonalizzare la presenza reale degli stessi monopolisti legali, il potere dei quali non subisce alcun limite davvero efficace che non trovi fondamento nella resistenza del popolo.
Sempre a partire dal Novecento, lo Stato ha esteso il controllo su banche e credito: anche in questo caso qualsiasi gruppo di persone che possieda il potere assoluto di stampare moneta tenderà inevitabilmente a farlo, dato che il potere di creare moneta senza vincoli, a parte la distruzione dell’affidabilità dell’intermediario dello scambio in oggetto, è quanto di più irresistibile si possa desiderare.
La chiave di volta trascurata dal liberalismo è allora proprio il monopolio legale della violenza, cioè quella barriera legale che consente di compiere legalmente attività aggressive su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio, da cui discende la suddivisione tra produttori, “tax payers”, e predatori, “tax consumers”, e l’articolarsi delle relazioni reciproche di dominio e sottomissione.
Di conseguenza, il monopolio legale della violenza non è funzione della “rule of law”, cioè del processo spontaneo di formazione della legge, della legge che trova la sua origine non nella decisone dell’autorità ma in un spontaneo processo evolutivo di selezione culturale, bensì della “rule of lawyers”, che può sfociare anche in versione “polizeistaat”, cioè del processo top-down della formazione della legge, cioè della legge, o meglio legislazione, dipendente dalla volontà dell’autorità.
In base a quanto, i limiti che il potere sovrano si autoimpone non forniscono alcuna garanzia alle libertà e alle proprietà, oltre a quelle fornite dall’equilibrio tra Stato e forze private, in quanto il monopolio legale della violenza è in grado di concedere allo Stato la condizione di eludere le proprie stesse leggi, evitando di applicarle, interpretandole o disattivandole con specifiche norme d’attuazione.
La progressione logica dello Stato
La progressione logica (non storica) dello Stato ha due limiti estremi: “dal limite estremo in cui i suoi obiettivi non sono per la stragrande maggioranza in competizione con quelli dei suoi cittadini (sudditi), al limite estremo in cui lo Stato è arrivato a possedere la maggior parte della loro proprietà e libertà”.
Come la comune attività privata si consuma con il suo impegno nella concorrenza, così lo Stato è logicamente orientato a trasformarsi da “protettore di modeste dimensioni”, in una “bestia da soma redistributiva”, in uno sgobbone dispensatore di crescenti politiche allocative e redistributive (con l’alibi fragile, ma politicamente efficace, di ottenere un sistema più giusto) e in seduttore delle maggioranze democratiche, che mira a trascinare dalla sua parte; infine, come la comune attività privata si sforza di primeggiare, così lo Stato si sforza di ottenere “attributi totalitari”.
L’albero genealogico della maggior parte degli Stati risale alla sconfitta di un popolo da parte di un altro e più raramente all’influsso di un capo vittorioso e del suo gruppo di guerrieri sul proprio popolo; e quasi sempre a seguito di una migrazione.
Lo Stato strappa ai propri cittadini (sudditi) l’obbedienza politica ricorrendo alla triade “legittimità”, “repressione” e “consenso”.
La legittimità garantisce l’obbedienza indipendentemente dalla speranza di essere ricompensati e dalla paura di essere puniti; tranne che nel lungo periodo, lo Stato non può produrne di più per propria scelta.
Nel farsi obbedire, le sue alternative sono quindi sostanzialmente ridotte a varie combinazioni di repressione e consenso, sebbene contino, ovviamente, i vantaggi di cui potrà godere grazie alla legittimità.
Possiamo definire il consenso allo Stato come un accordo implicito con cui lo Stato separa alcuni cittadini (sudditi) dagli altri e li ricompensa a spese di quest’ultimi, in cambio di qualche comportamento appropriato e favorevole che può andare dal sostegno militante attivo all’obbedienza passiva al potere dello Stato.
Per motivi che possono sembrare validi in un certo momento, e dei quali in seguito ci si può pentire, lo Stato repressivo considera solitamente opportuno sedurre alcuni di coloro che aveva prima represso, affidandosi maggiormente al consenso; tale processo combina misure di ampliamento della democrazia politica con gesti di buona volontà e ciò fa dello Stato fonte di nuovi conflitti e divisioni, dato che, per sollecitare il sostegno di alcune o vaste parti della società, deve promettere benefici sostanziali sottratti ad altri settori; un secondo effetto di questo processo, è, ovviamente, un aumento delle dimensioni e della sfera dell’intervento statale.
Articolato sostanzialmente nella dinamica fra repressione e consenso, lo Stato tende pertanto a sostituire la prima con quest’ultimo; lo Stato, poco alla volta, attraverso questa sostituzione, finisce per generare un imponente processo allocativo e redistributivo di stampo arbitrario, a favore di alcuni individui e dei gruppi che lo supportano e che entreranno per questo in lotta tra di loro, per ottenere questi benefici, escludere altri dall’accederne e per conquistare il controllo dell’apparato statale.
Tuttavia, i guadagni redistributivi tendono a generare una dipendenza sia a livello individuale che di gruppo e mentre nello stato di natura, cioè nella Società senza Stato, l’afflusso di persone in gruppi di interesse viene tenuto sotto controllo dal rischio (potenziale o reale) del “free-riding”, l’emergere sempre più dello Stato come fonte di guadagni redistributivi permette e incoraggia la formazione incontrollata di gruppi che mirano a chiedere tali vantaggi; questo si verifica perché i gruppi di interesse che chiedono favori allo Stato possono sopportare il free-riding tra i loro membri, che, invece, distruggerebbe i gruppi volontari che agiscono sul mercato.
Ciascun gruppo di interesse, a sua volta, è stimolato a comportarsi da free-rider in relazione al resto della società e lo Stato è il mezzo che lo consente senza incontrare forti resistenze.
Di conseguenza, se da un lato l’avanzare del consenso concede allo Stato di ampliare le sue dimensioni e la sua sfera di intervento, dall’altro, giunti a un certo punto, porta come risultato un enorme intrico di sotterfugi e favori asimmetrici, a livello industriale e occupazionale, senza né capo né coda; in altri termini, un “churning”, cioè una sorta di frullato, di rimescolamento complesso, opaco e indecifrabile di operazioni finanziarie statali.
Nello stadio del churning, il sistema redistributivo è diventato ormai sfuggente al controllo dello Stato stesso, cioè una foresta inestricabile di pretese rivendicate e di vantaggi elargiti, prodotta dagli effetti cumulativi involontari della spasmodica ricerca del consenso, che genera molte turbolenze, e porta con sé molte frustrazioni e delusioni.
Promettendo quindi sempre più benefici, in cambio di una crescente addomesticazione delle masse, lo Stato giunge a una condizione in cui protegge in misura soltanto marginale i diritti individuali e la proprietà, disincentiva la produzione di ricchezza e le relazioni di mercato a somma positiva (sostituite da transazioni a somma negativa fatte da sussidi e “government spending”) aumentando i costi di transazione e rivelando colossali squilibri generazionali e la sproporzione fra beneficiari e tartassati; nel frattempo, l’essere umano, con l’avanzare del dominio dello Stato, disimpara tendenzialmente a essere libero, seguendo l’illusione che il progredire dell’influenza dello Stato sia premessa anche della libertà.
Giunto nel churning, lo Stato ha quasi completato la sua metamorfosi: non è più il seduttore riformista ed è lontanissimo dall’essere uno Stato minimo, ma è una bestia da soma redistributiva, prigioniera appunto degli effetti cumulativi involontari della sua ricerca spasmodica di consenso, cioè è uno Stato-sgobbone.
Quasi completato appunto, perché con un tipo più elevato di razionalità, lo Stato potrebbe arrivare a emanciparsi dai vincoli del consenso e dare così compiutezza alla sua razionalità.
Nel passaggio dallo Stato-sgobbone a uno Stato-padrone totalitario, lo Stato non riacquista autonomia d’azione in un solo colpo, con una mossa pianificata in precedenza; se non altro all’inizio, questo percorso sembra più quello di un sonnambulo che un conscio progresso verso un obiettivo chiaramente percepito.
Un passo per volta, lo Stato può pertanto arrivare alla “piena realizzazione di sé”, dato che gli effetti cumulativi delle politiche di consenso hanno come esito finale quello di modificare il sistema sociale in modo da massimizzare il potenziale del potere sovrano e di consentire allo Stato di realizzare pienamente questo potenziale.
Le politiche cui tende, infatti, a scivolare lo Stato che gestisce un’economia mista eroderanno involontariamente gran parte dell’autonomia della società; quello che il Manifesto comunista chiama la “battaglia vittoriosa della democrazia” per “strappare, per gradi, tutto il capitale alla borghesia, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato è il completamento di tale processo”.
In tal senso, è del tutto indifferente sapere se la piena realizzazione di sé dello Stato viene instaurata trasferendo formalmente la proprietà di tutti i mezzi di produzione allo Stato o se, invece, la proprietà viene lasciata nominalmente ai (finti) proprietari e la socializzazione consiste nel controllo e nella direzione pressoché totale della vita dei cittadini (sudditi) da parte dello Stato.
Con la piena realizzazione di sé, lo Stato centralizza e unifica il potere politico con quello economico, direttamente o indirettamente, creando un sistema incompatibile con le regole classiche della democrazia di accesso al potere e che non è in grado di funzionare secondo quelle stesse regole.
Con la piena realizzazione di sé, lo Stato finisce, di fatto, per possedere i propri cittadini (sudditi); il potere politico ed economico è fuso, direttamente o indirettamente, in un unico potere statale, cosicché sostanzialmente ogni aspetto della vita del cittadino (suddito) viene governata da un’unica relazione comando-obbedienza, priva di sfere pubbliche e private separate, di centri di potere compensativi, di santuari e senza nessun “altro” dove andare.
Con la piena realizzazione di sé, lo Stato: esigerà “un assoggettamento dello stile di vita e del carattere delle persone a quanto da esso offerto e desiderato“; terrà “la sua sorveglianza e capacità repressiva costantemente elevatissime”, dato che queste devono arginare non soltanto la disobbedienza politica, ma anche la pigrizia e il free-riding; si adopererà “in modo oppressivo per evitare che scappino dai suoi confini quello che esso ritiene essere risorse e per evitare l’arrivo di qualsiasi influenza straniera discordante“.
Con la piena realizzazione di sé, la gestione dei cittadini (sudditi) da parte dello Stato diviene simile a quella che un proprietario di una piantagione aveva nei confronti dei suoi schiavi.
Con la piena realizzazione di sé, lo Stato avrà così massimizzato il proprio potere sovrano, il che non significa che lo Stato potrà sedersi in poltrona a contemplare il suo progetto finito.
Qualsiasi assestamento delle relazioni tra società e Stato, di qualsiasi stadio, non può mai, infatti, considerarsi per definizione, sia in un verso che nell’altro, immutabile, in quanto prodotto dell’azione e dell’interazione umana in politica.
Il destino dello Stato, compreso la sua stessa esistenza, dipende quindi sempre, in ultimo, dalla misura in cui le persone vogliono assecondare la volontà dello Stato o resistergli.
Sfatare i luoghi comuni
E’ luogo comune sostenere la seguente tesi: “lo Stato è necessario a causa dell’esistenza dei cosiddetti beni pubblici, cioè per via di merci o servizi che ognuno desidera di cui però la società non è in grado di assicurare un’adeguata produzione senza l’intervento statale, in quanto i relativi benefici sono talmente dispersi tra la popolazione, che nessuno, in assenza di questo intervento, ne produrrà mai a sufficienza”.
In realtà, esistono semplicemente i beni, o meglio “cose” che vengono considerate beni: per alcuni sussiste la “presenza” di rivalità nel consumo e, nel contempo, “escludibilità” nel consumo (in tal senso, “privati“) e per altri sussiste, invece, l’”assenza” di rivalità nel consumo e, nel contempo, la “non escludibilità” nel consumo (in tal senso, “pubblici“).
Detto quanto, per ogni bene, che sia pubblico o privato, chi stabilisce, di volta in volta, quando la produzione è da ritenersi adeguata? Come si fa ad affermare che senza lo Stato non ci sarebbe un’adeguata produzione di quel bene?
La suddetta tesi quindi non solo pretende di effettuare “comparazioni interpersonali di utilità“, comparazioni, in realtà, “impossibili da effettuare“, ma poggia anche sulla presunzione infondata che esistano “preferenze rivelate semplici” e “preferenza reali a lungo termine” o “non confuse” e che lo Stato sia in possesso di conoscenze migliori rispetto a chiunque altro per affermare le preferenze reali a lungo termine o non confuse.
Di conseguenza, la tesi della “necessità dello Stato a causa dell’esistenza dei cosiddetti beni pubblici” è semplicemente una “fallacia logica” .
E’ luogo comune sostenere che solo un soggetto col monopolio legale della violenza può fornire una situazione di diffusa armonia.
Tuttavia, è proprio l’ordine internazionale corrente a smentire quest’ultima affermazione; attualmente, infatti, su quell’unica comunità di persone chiamata esseri umani all’interno di quell’unico territorio denominato pianeta Terra, non esiste un super-Stato mondiale, ma tanti Stati nazionali, ciascuno con le proprie armi, il che quindi significa che le relazioni tra gli Stati nazionali si trovano, di fatto, immerse in uno stato di natura come quelle interne a qualsiasi Società senza Stato e, ciò nonostante, a farla da padrone non è una situazione di guerre permanenti tra Stati e nemmeno continuamente furti, inadempienze nei pagamenti, confische, comportamenti parassitari su scala internazionale, con i contratti ridotti a inutili strumenti.
Anzi, nell’ordine internazionale corrente, i diversi Stati, di norma, cooperano in una situazione di vera e propria pace armata e non esitano a partecipare apertamente al commercio, agli investimenti, ai prestiti internazionali, seppur in assenza di un super-Stato in grado di far rispettare i contratti nella selva delle diverse giurisdizioni nazionali.
Di conseguenza, sostenere che senza un monopolio legale della violenza è impossibile trasformare una situazione di conflitto generale in una di diffusa armonia è, ovviamente, “un’altra fallacia logica” .
Oltre lo Stato: la Società senza Stato
Qualcuno potrebbe obiettare che lo stato di natura è praticabile soltanto tra nazioni e non anche tra uomini e gruppi di uomini.
Stante, prima di tutto, che è impossibile dimostrare la necessità logica della suddetta affermazione, per smontare questa obiezione ci si può avvalere, inoltre, del saggio “La Società contro lo Stato”, dell’antropologo francese Pierre Clastres, in cui vengono descritte quelle comunità amerinde che vivono il loro interno in una situazione di diffusa armonia e nello stato di natura, cioè senza un monopolio legale della violenza – il che dimostra la fallacia logica del sostenere che lo stato di natura non è praticabile tra uomini e gruppi di uomini.
Il fatto poi che queste comunità senza Stato descritte siano rappresentabili come tecnicamente primitive, non deve far pensare che lo stato di natura tra uomini e gruppi di uomini, piuttosto che tra nazioni, abbia a che fare con il livello di civilizzazione tecnica; queste società descritte da Claistres sono, infatti, vere e proprie “società dell’abbondanza”, cioè facilmente in grado di produrre eccedenze, dato che non esiste nessun impedimento specifico alla divisione del lavoro, ma semplicemente ognuno dei suoi componenti non assegna ai beni che possono essere generati dalla divisione del lavoro un gran conto – al lavoro si preferisce fare altro ed è per questo che la produzione riservata allo scambio è quasi nulla.
Se da un lato pertanto lo Stato, il monopolio legale della violenza, deve essere considerato come un’istituzione storicamente contingente e non una necessità logica dell’interazione umana, dall’altro la Società senza Stato, lo stato di natura, non ha a che fare con il livello di civilizzazione tecnica, bensì con il potere.
Il potere costituisce una necessità intrinseca alla vita sociale stessa e, in conseguenza di ciò, non può darsi alcuna comunità senza una qualche manifestazione di esso, ma non sussiste necessità logica per cui la vita comunitaria debba fondarsi sul potere del monopolio legale della violenza, cioè fondarsi su un potere sovrano, un potere che si fissa in uno stato di dominio.
Con lo Stato, il monopolio legale della violenza, la comunità si divide tra decisori e pedissequi esecutori, è “il potere separato dalla società”; nulla allora più dello Stato si pone per definizione in contrasto con l’armonia diffusa di una comunità.
L’abolizione del monopolio legale della violenza non è in condizione da sola di eliminare ogni possibile pregiudizio arrecato ai legittimi diritti individuali e alla proprietà (poiché la giustizia non è in grado di cancellare la meschinità, né abrogare i limiti ontologici che contraddistinguono ogni esistenza umana), ma questa è la premessa necessaria, dato che venendo meno il monopolio legale della violenza viene necessariamente meno l’esclusione forzosa di altri “fornitori di servizi di difesa” per una comunità di persone all’interno di un determinato territorio, e conseguentemente anche la tassazione, aprendo così la strada a un ordine sociale policentrico.
La Società senza Stato è quindi la premessa necessaria perché si possa realizzare una società basata sul pieno rispetto delle legittime prerogative di ogni individuo, dato che in essa il potere non si separa dalla società, cioè non si fissa in uno stato di dominio.
In conclusione, se il rispetto della libertà rappresenta il fine supremo, non è possibile fare affidamento sul monopolio legale della violenza, cioè sullo Stato.
Riferimenti bibliografici
Anthony de Jasay, The State, Liberty Fund, Inc., Indianapolis, 1998 (edizione originale: 1985).
Pierre Clastres, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique, Minuit, Parigi, 1974.