 DI REDAZIONE*
DI REDAZIONE*
Il problema dell’euro è sempre in discussione. La recente scomparsa di Carlo A. Ciampi ha fornito l’occasione per moltiplicare gli interventi. Ma non passa giorno in cui non vengano espressi pareri sull’argomento e in cui, in una misura o nell’altra, alla moneta europea non vengano imputate le più diverse responsabilità. Purché accadute dopo l’adozione dell’euro, molte delle cose che non piacciono vengono direttamente attribuite alla valuta comune, trasformando così il “post hoc” in un “propter hoc”. E si trascura spesso di rammentare i benefici di cui abbiamo goduto con l’introduzione della nuova moneta.
Per inquadrare correttamente la questione dell’euro, è necessario comprendere che esso è una risposta al problema del nazionalismo monetario. Su tale tema, in pieno Ottocento, il noto economista inglese John Stuart Mill ha scritto: “permane tanta barbarie nei rapporti fra i paesi più civili che quasi tutti quelli che beneficiano dell’indipendenza preferiscono affermare la propria nazionalità conservando, a scapito di se stessi e dei vicini, una propria moneta”. Nel corso del Novecento, quasi alla vigilia del secondo conflitto mondiale, è toccato poi a un altro economista inglese, Lionel Robbins, sostenere che “di tutte le forme di nazionalismo economico, quello monetario è il più pernicioso”.
Se le parole di Mill sembrano rappresentare un’astratta petizione di principio, quelle di Robbins ci fanno capire che il nazionalismo monetario è uno degli strumenti di quel nazionalismo economico che per lungo tempo, pur promettendo il contrario, ha immiserito la vita degli uomini. Mediante il protezionismo, il potere politico avvantaggia gruppi privilegiati di produttori. E la “protezione” viene posta sulle spalle del resto dei cittadini: perché devono pagare prezzi maggiori di quelli che pagherebbero in assenza dell’intervento protezionistico e perché tale intervento sottrae risorse ai settori più efficienti e le convoglia verso quelli protetti. Si tratta di una vera e propria dilapidazione, che viene spacciata per tutela degli interessi nazionali. Ed è stata probabilmente questa la prima e più importante acquisizione della teoria economica, nata come critica dello stato interventista, come ribellione nei confronti del dirigismo statale, cioè a dire della sistematica prevalenza degli interessi di gruppi ristretti di produttori a scapito di tutti i consumatori.
Anche il nazionalismo monetario è una forma di protezionismo. Utilizza la svalutazione della moneta nazionale per rendere competitivi i beni prodotti internamente. Ma i benefici sono solo provvisori. Le esportazioni sono sùbito facilitate: costano infatti di meno agli acquirenti che spendono una moneta che non è stata parimenti svalutata. Ma il costo delle importazioni aumenta, provocando un conseguente aumento dei prezzi interni. Ciò significa che, non appena il processo di aggiustamento dei prezzi sarà completo, gli effetti favorevoli della svalutazione del cambio si esauriranno. Senza dire che, se poi anche gli altri paesi svalutano (dipende dalla misura), i vantaggi provvisori potranno essere minimi o potranno non esserci affatto.
Qual è allora la prospettiva? Aprire una guerra delle svalutazioni competitive? È questa la via che porta all’instabilità internazionale: masse considerevoli di capitali a breve termine si accumulano nei “diversi centri”, pronti a trarre vantaggio dalla modifica dei rapporti valutari. Accade che, “fino quando sarà possibile modificare il corso dei cambi, esisterà pure una situazione per cui, irrimediabilmente, gli uomini prudenti cercheranno di evitare le perdite e gli uomini avventurosi cercheranno di guadagnare” (Robbins). È questo che si vuole?
Robbins e Hayek hanno condotto negli anni Trenta una strenua battaglia contro il nazionalismo monetario. Essi pensavano alla creazione di aree monetarie, dentro le quali l’offerta di moneta avrebbe dovuto essere articolata in regime di concorrenza. Ritenevano perciò necessario il decentramento della riserva bancaria. Non è un caso che, in tempi più vicini a noi, Hayek sia giunto a sviluppare l’idea della “denazionalizzazione” della moneta, una strada su cui stanno ancor oggi lavorando Lawrence H. White e George A. Selgin.
La creazione dell’euro non ha seguito tale itinerario. Non è stata presa in considerazione neanche la proposta di quegli studiosi di Kiel, che negli anni Settanta avevano avanzato l’ipotesi della creazione di una moneta parallela. L’euro è stato il prodotto di quella forma estrema di “ingegneria” istituzionale, che si rifiuta di affidarsi alle soluzioni generate dal processo sociale allargato. E tuttavia anche le istituzioni create intenzionalmente generano esiti inintenzionali. Jesús Huerta de Soto, economista ed euroscettico, ha con onestà riconosciuto che l’introduzione dell’euro “ha portato nella maggior parte dei paesi dell’Europa continentale alla sparizione del nazionalismo monetario e dei saggi di cambio flessibili”. Il che ha impedito ai governi nazionali di “manipolare la propria moneta” e di ingannare con promesse illusorie i propri cittadini.
Se avessimo saputo trarre vantaggio dall’esistenza dell’euro, molti capitali sarebbero potuti affluire nella nostra economia, perché al riparo dalle consuete svalutazioni valutarie. E avrebbero potuto favorire la crescita della nostra produttività. Ciò di cui abbiamo tremendo bisogno. Ma i capitali si trasferiscono per portare a compimento progetti profittevoli e non per realizzare della beneficenza. Se l’ombrello dell’euro non ci ha aiutati, vuol dire che sono mancate altre condizioni. Il che è dipeso esclusivamente dalle nostre politiche. Nel mondo descritto da George Orwell, si dava il nome di pace alla guerra e quello di libertà alla schiavitù. Per fortuna, non viviamo in quel mondo. Sono però numerosi quanti oggi pensano che lo sperpero delle risorse possa darci lo sviluppo economico e che l’abbandono della gozzoviglia finanziaria, da cui ha origine il nostro spaventoso debito pubblico, ci condanni inevitabilmente al ristagno. Più di quelle di un qualunque economista, sono allora le parole di Federico Garcia Lorca che possono venirci in soccorso: “Non è sogno la vita, all’erta, all’erta, all’erta!”.
di Lorenzo Infantino da “Il Foglio” del 12 ottobre 2016


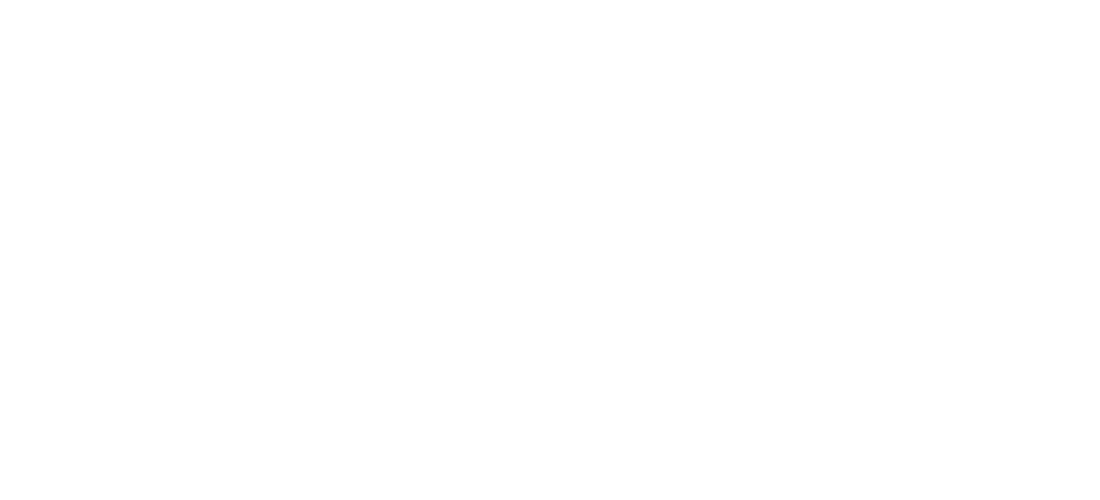

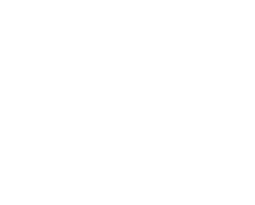
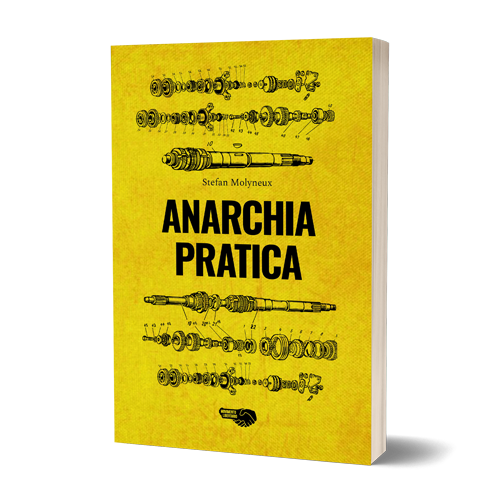



Una moneta nazionale viene comunque prezzata dal mercato in ambito internazionale (gli scambi avvenivano in “oro equivalente”, se non erro), per cui la sua eventuale svalutazione produce effetti reali solo all’interno dei confini nazionali.
Negli anni ’80, gli anni dello SME, abbiamo fatto i furbi perche’ pur essendo legati da accordi di cambio fisso a livello di area pre-euro, abbiamo continuato a stampare moneta allegramente nel nostro paese, fino al “re nudo” e crollo del 1992. In quei periodi di “allegria”, gli anni ’80, quando cambiavamo le lire in marchi, avevamo un potere di acquisto maggiorato in germania, e se non era come essere in sudamerica, quasi. Evidentemente c’era il trucco… Questa forse si puo’ definire “svalutazione competitiva”.
La svalutazione in italia era continua, dopo gli anni ’60, perche’ lo Stato pagava le sue spese e clientele stampando moneta, ed era abituato a farlo nella misura in cui la crescita dell’economia reale era a due cifre e la cosa funzionava, mentre quando una volta raggiunta la prosperita’ la crescita ha cominciato a rallentare, e la spesa dello stato a crescere a dismisura, dalla meta’ degli anni ’60, ogni stampa di moneta ha provocato il suo deprezzamento e sono cominciati i dolori, e la guerra fra i vari attori economici per “mantenere il potere d’acquisto” contrattando continui aumenti – da cui una delle ragioni del terrorismo rosso di quegli anni.
En passant, quando la lira era saldamente ancorata al dollaro (per circa vent’anni del dopoguerra il cambio e’ stato fermo a circa 680 lire per dollaro), l’italia ha visto il di gran lunga maggiore periodo di crescita dell’intera sua storia unitaria.
Sì, ma “grande” non sempre corrisponde a un aspetto fisico – geografico.
Non ho menzionato grandezza fisica, intendevo “grande” nel senso economico e politico.
Più grande è il monopolio, più grande è l’entità dei danni. Non servono dati empirici per saperlo.
Credo che i danni di un monopolio non siano misurabili con la sua maggiore o minore estensione territoriale. Ritengo che il professor Infantino abbia voluto dire che non abbiamo saputo approfittare degli effetti collaterali (e da qualcuno indesiderati) di un male.
Ragionamento piuttosto confuso. La concorrenza è positiva anche tra mali. Un monopolio nazionale è meno dannoso di uno pan-europeo.