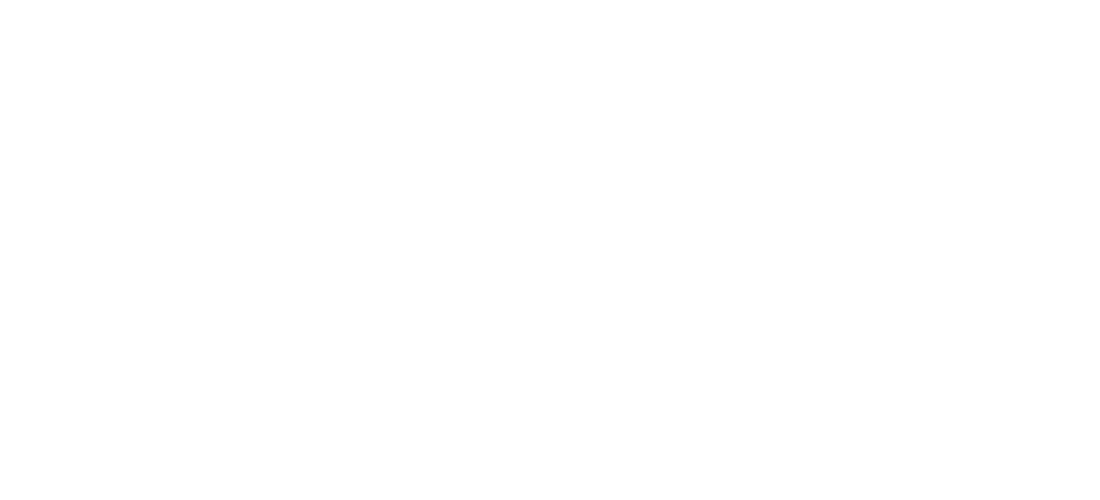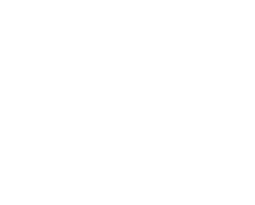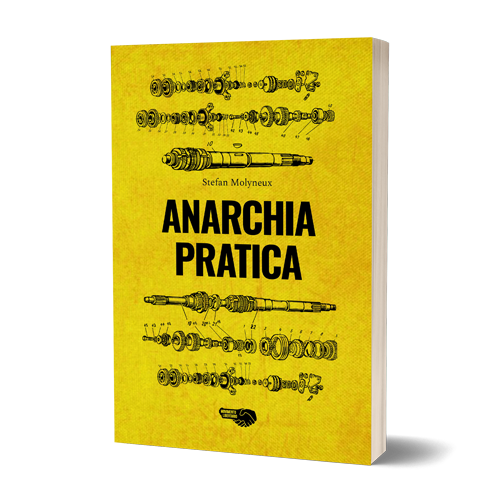“Il discorso del Presidente a Strasburgo contiene una riaffermazione ma anche un cambiamento di rotta: l’austerità ha fatto il suo tempo, di troppa austerità si muore… La domanda – una domanda che è in fondo rivolta alla scienza economica – era questa: l’austerità potrebbe stimolare l’economia?… Certamente, quanti come il Presidente oggi condannano l’austerità fine a se stessa si preoccupano allo stesso tempo di raccomandare conti in ordine, di non cercare lo stimolo in un disordinato ritorno a una finanza pubblica allegra” (F. Galimberti)
La scorsa settimana il presidente della Repubblica è stato al Parlamento europeo, dove ha tenuto un discorso che in Italia è stato quasi unanimemente osannato, ma che non conteneva nulla di originale e che, se pronunciato da un socialista qualsiasi, con ogni probabilità non sarebbe neppure stato notato. E invece sono stati usati fiumi di inchiostro da parte del folto numero di commentatori che applaudono ed esaltano qualsiasi cosa dica o faccia Napolitano, senza se e senza ma. Sul fatto che la parola “austerità” sia stata abusata negli ultimi anni ho già scritto in più occasioni: si è spacciata una politica fiscale restrittiva fortemente sbilanciata su aumenti di entrate come se fosse una politica austera, quando una vera austerità consisterebbe in una vigorosa riduzione di spesa pubblica e dell’invadenza dello Stato.
Mentre una riduzione di spesa, dopo una iniziale contrazione del Pil (per il semplice fatto che, ancorché il concetto sia discutibile, ogni euro di spesa pubblica è considerato pari a un euro di maggiore Pil), può, se accompagnata da una riduzione della pressione fiscale, favorire una ripresa economica grazie alla maggior quantità di risorse lasciate dallo Stato a chi le ha legittimamente generate, un incremento di tasse a spesa pubblica invariata o addirittura in aumento non può che strozzare l’economia, a maggior ragione quando si parte da livelli di pressione fiscale già elevati. Detto, quindi, che non tutte le politiche di aggiustamento dei conti pubblici sono qualitativamente uguali, veniamo all’invocazione presidenziale: meno “austerità”, ma senza “un disordinato ritorno a una finanza pubblica allegra”.
I keynesiani moderati lo sostengono da sempre: un po’ più di deficit oggi, ma con l’impegno a un consolidamento nel medio lungo periodo. Se non fosse che ogni forma di interventismo introduce distorsioni nella domanda e nell’offerta che ritengo sia meglio evitare, si potrebbe concedere a qualche keynesiano anche di essere in buona fede. Il problema è che gli interventi sono fatti da politici, per i quali il lungo periodo non è neppure la prossima scadenza elettorale, bensì il sondaggio del giorno dopo. Ne consegue che l’aumento, ancorché moderato, del deficit, anche al netto delle distorsioni a cui ho fatto cenno, ben difficilmente sarà temporaneo, senza un intervento esogeno a imporre una correzione (si chiami spread o troika, poco importa). Da questo punto di vista aveva ragione Milton Friedman quando sosteneva che “nulla così permanente come un programma provvisorio del governo”. Infatti, quando l’economia arranca il deficit viene giustificato per rilanciarla, mentre quando sembra essersi ripresa, non pare giusto “tarpare le ali” alla crescita riducendo il deficit.
In sostanza, il momento per tirare la cinghia non arriva mai volontariamente. Eppure basta un semplice ragionamento: perché una persona che spende ogni anno più del reddito prodotto è destinata alla rovina in tempi brevi mentre non dovrebbe esserlo uno Stato? I fautori della tesi secondo cui “un po’ di deficit non è un problema” sostengono che lo Stato sia diverso da una persona e in parte sicuramente ciò è vero, non fosse altro per il fatto che nessun privato può estorcere denaro ad altri senza essere considerato un criminale e per questo essere perseguito. Ciò non toglie che accumulare deficit conduce a un forte aumento del debito (e in Italia ne sappiamo qualcosa) e che l’idea di monetizzarlo conduce prima o poi a una perdita di fiducia nella moneta e nel forte calo del suo potere d’acquisto. Non esistono, quindi, formule magiche: la ricchezza non si crea dal nulla, né può essere creata dallo Stato, la cui attività è al più di redistribuire la ricchezza esistente (sprecandone non poca). Resterebbe, infine, una domanda da porre a Napolitano e ai suoi adulatori: se il limite del 3 per cento del Pil non è sufficiente, lo sarebbe il 4 o il 5 per cento? Cosa impedirebbe, una volta raggiunto il nuovo limite, di invocare un ulteriore sforamento per fare ancor più “bene” all’economia?