Quanti equivoci, quanti deragliamenti, quante concessioni a culture antitetiche (e, vorrei aggiungere, ai favori di opinioni pubbliche addomesticate da decenni) si nascondono sotto il generoso ombrello del moderno liberalismo? Se è vero che le stesse democrazie occidentali pongono crescenti limitazioni alla libertà degli individui e che i (più o meno sedicenti) partiti liberali non sembrano, in particolar modo, sollecitati da certe drammatiche ristrettezze, non è forse (tornato) il tempo di interrogarsi, di domandarsi che cosa sia o si debba intendere per “liberalismo”? E quale, dunque, possa e debba essere l’agenda dei liberali di fronte ad una crisi globale di cui non si vede il termine e che è prima di tutto crisi di cultura (o di culture) e solo dopo finanziaria, economica, sociale e politica?
Che si sia o meno in possesso di risposte ai numerosi quesiti, non sarà dunque un’esperienza banale ripercorrere con la doviziosa ricostruzione di Antonio Masala (ricercatore di Filosofia Politica dell’IMT Alti Studi di Lucca, nel suo “Crisi e rinascita del liberalismo classico”, Edizioni ETS, pp. 348, € 30,00) la vicenda della officina del pensiero che, a partire da Carl Menger e Ludwig Von Mises, passando per Frederick Von Hayek e sfiorando il cosmo libertarian con Bruno Leoni (filosofo e giurista assai apprezzato nel mondo anglosassone, che i liberali italiani hanno per lo più ignorato), recupera il liberalismo delle origini e offre una chiave di lettura filosofica delle questioni più spinose della contemporaneità.
Per gli esponenti della Scuola austriaca il collettivismo e l’interventismo statale hanno non solo ispirato i regimi totalitari ma anche pervaso le democrazie occidentali, sussistendo tra essi differenze di mero grado e non di sostanza. La straordinaria attualità (e opportunità) dell’opera emerge giusto nella riflessione sul rapporto tra liberalismo e democrazia che, come l’Autore sostiene, “è uno degli elementi dirimenti per la rinascita del liberalismo classico”; ed è – aggiungo – la linea di faglia da cui potrebbero scaturire, ove non risolta, autentiche scosse politico-istituzionali. Qui corre l’opportunità di richiamare – per parziale prossimità tematica, anche se con struttura e impostazione assai diverse – la critica inaugurata da Frank Karsten e Karel Beckman nel loro “Beyond Democracy”, che si rivolge, talvolta con ironia (“Democracy is the will of people. Every morning I am surprised to read in the newspaper what I want”), ai 13 miti su cui si fonda la perdurante ‘fede’ nella democrazia.
La democrazia non è – contrariamente a quanto gli stessi liberali, sovente, reputano – lo sviluppo naturale del liberalismo, così come un liberale non è necessariamente un democratico. Libertà ‘negativa’ e ‘positiva’ (rifacendosi alla distinzione di Isaiah Berlin) non sono sfumature di un unico colore bensì “due atteggiamenti profondamente divergenti e inconciliabili nei confronti dei fini della vita”. Non è per questo anti-democratica la Scuola austriaca: essa vede nella democrazia una necessità almeno quanto un pericolo e, per ciò, è scettica e indisponibile ad accettarne qualsivoglia esito. Leoni nel suo “Freedom and the Law” individua ciò che è potenzialmente totalitario nel processo legislativo e – posto che “in ogni società (…) le convinzioni riguardo alle cose da non fare sono molto più omogenee di quelle sulle cose da fare” – reputa che il compito del diritto dovrebbe essere prevalentemente negativo.
Per il liberale “classico” le fondamentali preoccupazioni dello Stato si articolano nella tutela e garanzia della vita, della proprietà e della libertà dei consociati. Apriti cielo: se oggi parli in questi termini ad un “liberale”, rischi di passare per matto o ti becchi la vieta predica sull’ingenuità. Le convinzioni collettiviste sono talmente radicate che gli stessi liberali non si accorgono che – come ha egregiamente sintetizzato Richard Epstein nel suo “Regole semplici per un mondo complesso” – non si può prendere sul serio “un ordinamento giuridico che dedica la fetta maggiore del suo impegno (…) a identificare e correggere i fallimenti del mercato risultanti da un’informazione asimmetrica e imperfetta nei rapporti di lavoro, piuttosto che a contenere la violenza nelle strade”. Le istanze in favore dei “nuovi” (e spesso controversi) diritti hanno gradualmente monopolizzato l’attenzione e gli sforzi, anche genuini, dei liberali moderni, mentre l’evoluzione dei sistemi democratici iniziava a mettere pesantemente in discussione i “vecchi” (e fondamentali) diritti. Di cosa, allora, conviene o è necessario occuparsi? E se la scelta cade – come sovente accade – sui nuovi diritti, come può un liberale sottovalutare il fatto che la soddisfazione di determinate pretese individuali passa inevitabilmente per un maggior intervento pubblico e quindi per una più intensa collettivizzazione? Non è questo – più propriamente – terreno di caccia del socialismo, ancorché nelle forme (anch’esse) moderne e un po’ edulcorate (ma pressoché identiche sul piano filosofico) della socialdemocrazia e del socialismo liberale? Il liberalismo si è conformato all’opinione corrente che molte delle storture presenti nelle dinamiche sociali siano dovute al mercato. E si è snaturato quando ha scartato – diciamo pure a priori – l’ipotesi che molte delle colpe attribuite al mercato siano in realtà colpe della politica, con ciò diventando una teoria dell’incremento del potere politico piuttosto che, come in origine, della sua limitazione.
“Crisi e rinascita del liberalismo classico”, che peraltro si giova di una ragguardevole bibliografia, offre l’occasione per una riflessione aggiuntiva che (a mio modesto avviso) ha grande importanza nell’opporre concetti assai chiari ad un immaginario (collettivo) apertamente fasullo. Mi riferisco al fatto che sovente l’idea liberale sulla limitazione del ruolo dello Stato viene confusa con una visione limitata della vicenda umana. Se, cioè, vale per lo Stato il trinomio vita-libertà-proprietà, allora l’individuo dei liberali è per definizione “limitato”, dedito cioè esclusivamente ai propri affari, a difendere il proprio orticello, a massimizzare i profitti e per nulla solidale. Questa è la vulgata grossolana di numerosi detrattori del liberalismo classico. A tale proposito giova senz’altro (ed è anzi una scelta azzeccata di questo Autore) la riproposizione della teoria della nascita inintenzionale dell’ordine come chiave di volta per comprendere la rinascita del liberalismo classico nel Novecento. Questa rinascita, cui ha dato anima la Scuola austriaca, parte idealmente da Bernard De Mandeville. E se “Mandeville condivide in partenza l’anti-aristotelismo di Hobbes”, le strade si divaricano nello spiegare la nascita dell’ordine sociale: si ha la socializzazione“perchè l’uomo, con l’evoluzione e il progresso, si accorge di quali siano i vantaggi della vita associata: prima con il difendersi dal pericolo comune delle bestie feroci e poi con l’invenzione delle lettere e il bisogno di un governo e di leggi scritte a garanzia dello scambio”. La cooperazione si impone come un fatto naturale, qui è già in nuce il pensiero di Adam Smith. L’interesse è un tertium genus tra ragione e passione ed il suo perseguimento in un processo di continuo adattamento conferisce grandezza alla costruzione sociale. Ecco perché la politica e il diritto non possono, non debbono interferire. Il loro compito è piuttosto mantenere le condizioni in cui questa inintenzionale cooperazione sociale possa perpetuarsi nel tempo. Dunque la limitazione dello Stato è funzionale a scongiurare indebite interferenze e a garantire la salvaguardia della vita, la tutela della proprietà e la libertà: queste sono (e devono restare) le sue preoccupazioni essenziali. Senonché, oltre quei confini apparentemente ottusi e limitati, c’è – semplicemente – la vita, ci sono le immense potenzialità degli individui – anche, se vogliamo, dal punto di vista della cooperazione e della solidarietà gli uni verso/con gli altri. Si può anche affermare, con Epstein, che l’insistenza sull’autonomia della persona e sul predominio della proprietà privata su quella collettiva, lungi dall’essere “un tentativo che mira a promuovere comportamenti avidi o egoistici”, all’opposto è molto più sensibile a qualsiasi preoccupazione comunitarista che non le soluzioni collettive solitamente sbandierate.
La vicenda umana è e resta inevitabilmente ricca, a maggior ragione se uno Stato guardiano si astiene dall’interferire nelle scelte individuali. Così si dilata lo spazio delle speranze, dei sogni, della volontà, della cultura, dell’ingegno, dei progetti, delle idee – quelle stesse idee cui Von Mises ha riconosciuto tanta importanza. E il richiamo di Von Hayek alle antiche virtù dei popoli anglosassoni (“l’indipendenza e la fiducia in se stessi, l’iniziativa individuale e la responsabilità locale, l’affidamento del successo all’azione volontaria, la non interferenza verso il prossimo e la tolleranza verso ciò che è diverso e stravagante, il rispetto per gli usi e la tradizione, e una sana diffidenza verso il potere e l’autorità”) è significativo: questi maestri del pensiero sono ispirati da una avversione nei confronti delle ideologie, dalla fede nei valori tradizionali, dal coraggio di difendere gli ideali e i valori che hanno reso le persone “libere e rette, tolleranti e indipendenti”. Essi hanno la convinzione che nel mondo umano l’influenza del singolo individuo sul fenomeno che viene studiato può talvolta apparire impercettibile, ma è in realtà sempre determinante. Per tutte queste ragioni l’umanesimo liberale, lungi dall’essere scarno, o rattrappito, si impone per ampiezza di vedute e per la particolare intelligenza dei processi storici e sociali. Gli procura nutrimento quell’individualismo metodologico che impone di non cedere mai alla tentazione di ridurre lo sviluppo della realtà a vicende di insiemi che non hanno né parola né volizione (come, ad esempio, la “società”, la “classe sociale”, ecc.).
Come è possibile non cogliere la grandezza e ricchezza dell’avventura individuale e – per conseguenza – di quella cultura che la vuole emancipata dal potere opprimente dell’iper regolazione e dell’elefantiasi politico-amministrativa, capace di autodeterminarsi e perciò sommamente responsabile?
Una profonda coerenza permea di sé i vari aspetti della filosofia liberale, come un cerchio che in qualche modo si chiude e il libro di Masala promette di scoprirla o di riconoscerla, a seconda dei casi. Tornare a e soprattutto ripartire dal liberalismo delle origini è un’opzione concreta a disposizione di quei liberali che vogliano sottrarsi alla cultura dominante e tornare a dire qualcosa – qualcosa di importante -, tenendolo alla larga da (umanissime) pulsioni nichiliste e/o autoritarie.


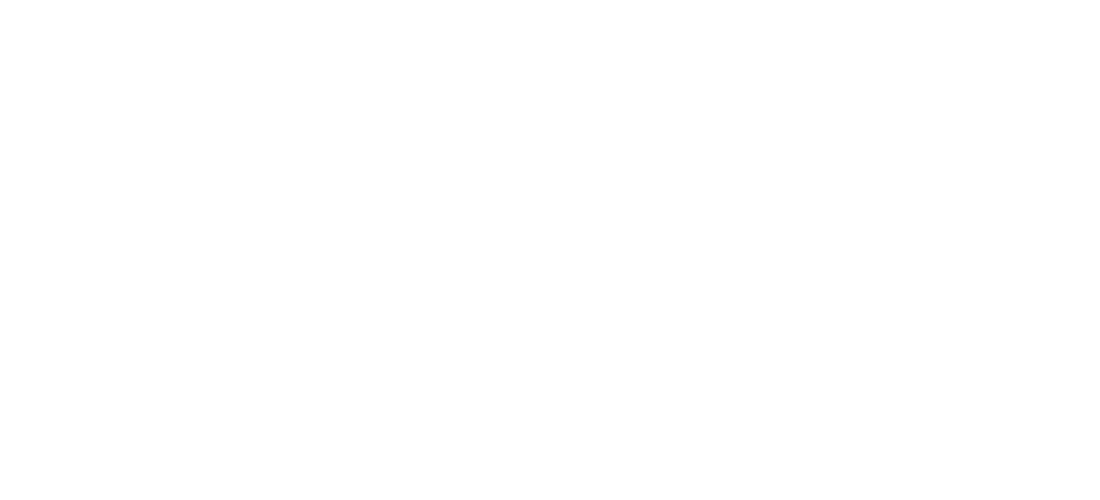
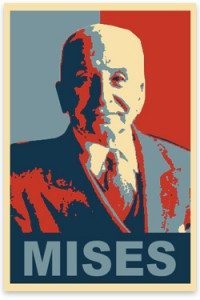

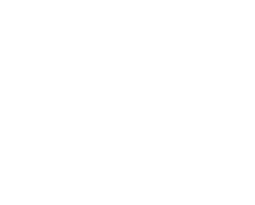
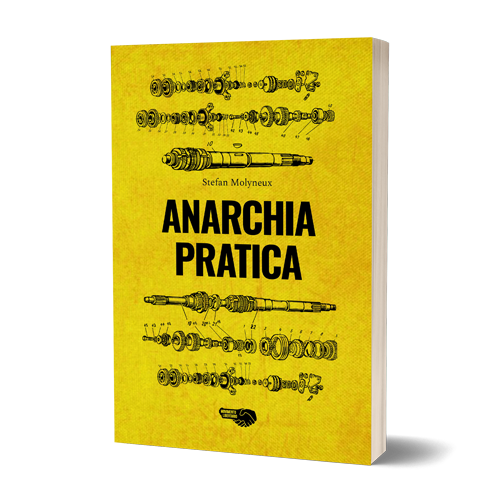



Grazie per questo interessante quanto illuminante articolo