 DIECI ANNI FA (10-8-2001) MORIVA IL PROFESSOR GIANFRANCO MIGLIO
DIECI ANNI FA (10-8-2001) MORIVA IL PROFESSOR GIANFRANCO MIGLIO
Il passaggio dal decisionismo alla Schmitt al federalismo libertario: così il pensiero di Miglio ha incontrato la modernità
DI CARLO LOTTIERI
Qualcuno certo sarà rimasto sorpreso, nel corso degli anni Novanta, di fronte a talune prese di posizione del professor Gianfranco Miglio. Dopo aver «importato» a Sud delle Alpi il realismo decisionista di Carl Schmitt e dopo essersi speso a lungo nel tentativo di persuadere la classe politica italiana della necessità di adottare un modello politico presidenziale (non «autoritario», ma certo «autorevole» e in condizione di garantire stabilità e durata all’esecutivo), l’ultimo Miglio ha offerto infatti più di una ragione di scandalo.
L’anziano professore dapprima si è proclamato favorevole a riforme di segno federale, quindi si è nettamente schierato a difesa del diritto di secessione, per poi infine giocare anche in prima persona un ruolo politico, ispirando la Lega Nord (di cui è stato senatore) e, dopo la rottura con quel movimento, le formazioni del centro-destra. Non solo: Miglio si è anche contraddistinto per iniziative culturali non facilmente riconducibili all’immagine stereotipata che di lui si erano fatti quanti lo avevano identificato con quel progetto di Seconda Repubblica che aveva elaborato alla testa del «gruppo di Milano». Ha riproposto il testo classico di Henry David Thoreau sulla disobbedienza civile e ha favorito la traduzione dell’opera principale di Daniel J. Elazar (massimo esponente del neo-federalismo) e del volume di Allen Buchanan sul diritto di secessione.
In questa pur evidente discontinuità vi sono, e vanno evidenziati, elementi di stretta connessione tra il decisionismo originario e l’esito federalista (venato di intonazioni libertarie) dell’ultimo e più maturo Miglio.
Pensare al politologo lombardo vuol dire riferirsi a uno studioso che durante la seconda metà del Novecento ha avuto pochi rivali, in Italia e fuori, nel suo tentativo di scandagliare con rigore scientifico la realtà del potere: evitando qualsiasi retorica e sforzandosi di osservare la politica quale essa è. Nel corso di questa ricerca, allora, non stupisce che egli abbia finito per elaborare un pensiero non privo di assonanze con quella linea di pensiero che – da Étienne de la Boétie fino a Murray N. Rothbard, passando per i libertari americani del XIX secolo – si è sforzata di sottrarre ogni maschera all’autorità politica.
Dietro alla virata degli anni Novanta, d’altra parte, non c’è solo la manifestazione di una consolidata attitudine «realista». Come egli medesimo ha più volte sottolineato anche in mirabili interventi parlamentari, il rigetto delle tesi decisioniste è nato in lui dalla stessa crescente consapevolezza che lo Stato moderno rappresenti, in quanto tale, un ferro vecchio: un arnese da gettare o, se si preferisce, un’istituzione da ripensare in modo radicale e che non può reggere, nella forma attuale, alle sfide dell’epoca contemporanea.
Per ritrovare le radici di tale evoluzione del pensiero migliano può essere utile richiamare taluni elementi della riflessione che egli svolse a metà degli anni Settanta, in un’Italia caratterizzata dall’avanzata crescita elettorale di un partito comunista che però – al contempo – stavano avviando un processo di avvicinamento a logiche welfariste e socialdemocratiche. Proprio entro tale contesto storico, ormai tanto remoto, Miglio sviluppa una riflessione generale che muove dalla constatazione dell’esistenza di due distinti poli della vita pubblica: quello dello Stato e quello del mercato.
Miglio evidenzia come questi due ambiti, in quanto elaborazioni umane, mostrino comunque taluni tratti comuni. La sua confidenza con la lezione elitista lo spinge in particolare a evidenziare come «in entrambi valgano da sempre, effettualmente, la regola ferrea della cooptazione, e il meccanismo delle consorterie». La pretesa weberiana di uno Stato impersonalmente neutrale gli appare insomma quanto mai ingenua e infondata, né egli pare gradire la tesi – allora tanto in voga – di quanti pretendevano di legittimare l’ordine capitalistico sulla base di argomenti «meritocratici» o ipotizzando uguali punti di partenza.
Al di là di ciò, a ogni modo, è pur certamente vero che la contrapposizione Stato e mercato rinvia a un «dualismo irriducibile», in virtù del quale l’apparato politico e il ceto imprenditoriale riescono a disporre di ingenti risorse finanziarie grazie a «due diverse convenzioni: rispettivamente il ‘diritto pubblico’ (Costituzione) e il ‘diritto privato’ (codici)». Se l’ordine statuale deriva dal comando gerarchico e dalla volontà costruttiva del ceto politico egemone, nel carattere naturalmente liberale delle relazioni mercantili Miglio riconosce anche l’espressione di un antico dinamismo imprenditoriale, che già nell’età medievale della lex mercatoria sul piano giuridico aveva saputo esprimere – come aveva evidenziato Levin Goldschmidt -«la pronta formazione internazionalmente uniforme del diritto commerciale e una conseguente continuità sorprendente dello sviluppo storico». Alla rigida determinazione degli obblighi imposti dal potere si contrappone quindi la spontanea elaborazione di un diritto che ignora i confini degli Stati nazionali e si distende liberamente nel tempo.
Dietro all’eterna e alterna oscillazione storica tra Stato e mercato Miglio rinviene allora due distinti obblighi. Nel mercato, in effetti, prevale l’obbligo-contratto quale frutto di un diritto che emerge dalla volontà degli attori, mentre all’interno delle relazioni statuali la scena è dominata dall’obbligo politico, il quale esiste in virtù di una pretesa unilaterale all’obbedienza:
«fra gli uomini sono possibili due tipi diversi, contemporanei ma irriducibili, di rapporto: l’obbligazione-contratto interindividuale (in cui si cerca la soddisfazione di singoli, attuali e determinati bisogni, e da cui nasce quindi il ‘mercato’), e il patto di fedeltà politico (in cui si cerca una garanzia globale per tutti i futuri, non ancora specificati bisogni esistenziali, e da cui nascono quindi appunto le ‘rendite politiche’)».
È sulla base di tali analisi che egli giunge a elaborare un’interpretazione quanto mai originale di quella dissoluzione sindacalistica della sovranità statuale che era sotto gli occhi di tutti nell’Italia degli anni Settanta. Quello che Miglio vede emergere è un assetto che definisce federativo-corporativo, nel quale «la sanzione per i patti violati, e la discriminazione fra interessi illeciti (‘parassitari’) e interessi legittimi (sacrosanti), non spettano più – almeno per un certo tempo – a un solo e convenzionale potere decisivo (sovrano), ma dipendono dall’equilibrio generale delle obbligazioni assunte dai gruppi corporati in campo, e quindi dalla materiale forza contrattuale di ciascuno di essi».
Fin dagli anni Settanta, allora, era possibile trovare in Miglio una serie di straordinarie intuizioni sul rapporto tra i due modelli fondamentali di relazione sociale e la lotta per le risorse. Le successive riflessioni migliane sulla natura del parassitismo statale e sul ruolo che la spartizione del «bottino» all’interno dei sistemi politici muovono da qui, così come la sottolineatura della centralità del contratto: da intendersi sia nell’accezione classicamente privatistica che in quella, non meno rilevante, che vede all’opera gruppi (professionali o territoriali che siano).
È attraverso queste analisi che riemerge in Miglio sia l’interesse al federalismo (un suo tema, in verità, fin dagli anni della Resistenza e de Il Cisalpino) che l’attenzione al mercato, inteso non solo quale sistema economico ma anche come premessa di ordini giuridici concorrenziali. Da qui proviene anche la riattualizzazione di tante ricerche del passato su istituzioni moderne in qualche modo eccentriche, non riconducibili al modello vincente statuale: centralizzato, nazionale, giacobino e impersonale. Dalla natia Como, d’altro canto, Miglio ha sempre avuto per la federazione svizzera quell’attenzione che – si può presumere – Johannes Althusius avrà riservato all’originale esperimento olandese delle libere Province Unite, tanto vicine alla sua piccola Emden.
Una delle riflessioni che hanno condotto Miglio ad allontanarsi dalle proprie posizioni originarie è stata la considerazione che l’invenzione dell’atomica e la conseguente fine della guerra globale (uno scontro giocato senza freni e in prima persona dalle grandi potenze implicherebbe la scomparsa dei contendenti) «l’avvento di un sistema contrattuale sia a questo punto una necessità storica».
Ormai inadeguato ad assolvere il proprio compito primario (la guerra, appunto), lo Stato moderno secondo Miglio appare però ancor più fuori gioco di fronte alle esigenze della produzione e del benessere. È soprattutto a partire da tale analisi, ancor prima che dalle precedenti considerazioni sul declino della dimensione conflittuale, che Miglio fa discendere la sua analisi sull’imperiosa riemersione del mercato e delle sue logiche: «per capire il cambiamento di fine secolo, dunque, è necessario comprendere la vocazione al contratto, al pluralismo e al federalismo che nasce dall’impossibilità di gestire altrimenti i bisogni dei governati. Questi infatti sono talmente vari che possono essere soddisfatti solo nel libero mercato». Miglio inizia così a collegare sempre più strettamente l’analisi spietatamente realistica dei sistemi statuali di dominio, la valorizzazione dell’efficacia e della civiltà degli ordini istituzionali policentrici (federali) e il dinamismo delle economie orientate al mercato, alla concorrenza, all’innovazione. Se anni fa qualcuno poté forse stupirsi di fronte alla decisione di inserire nella prestigiosa collana «Arcana Imperii»(lungamente diretta da Miglio stesso per le edizioni Giuffrè) un’antologia di scritti di Mises e Hayek a cura di Guido Vestuti, oggi è più facile capire le ragioni di quel volume, significativamente intitolato Il realismo politico di Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek. La successiva evoluzione di quel pensiero permette adesso di cogliere meglio l’unità di un progetto di cui molti ancora faticano a comprendere l’intima coerenza.
Anche quando tratteggia i non certo gloriosi destini futuri dell’ordine statuale ed esalta le logiche pattizie del federalismo e del mercato, egli rivendica costantemente il proprio sobrio spirito demistificatore: «Non sto disegnando un’utopia, o auspicando una trasformazione in meglio (chi potrebbe dimostrarlo?) dei sistemi politici ed economici del tardo secolo XX: ma cerco solo freddamente di descrivere il tipo di assetto istituzionale che si sta già faticosamente affermando. Io sto ai fatti, e soltanto ai fatti». E questi fatti gli sembrano suggerire l’attualità del «grande modello di federalismo universale (‘a scatole cinesi’) elaborato dai valenti giuristi calvinisti, come Giovanni Althusio, sull’esperienza delle città e degli Stati mercantili nord-germanici fra Cinquecento e Seicento: in un’età e in una civiltà squisitamente ‘europee’, che (non solo nell’Hansa) sperimentarono il massimo di espansione possibile del ‘contratto’ e del privato sul politico, alla vigilia dell’opposto trionfo ‘statalista’ delle monarchie assolute. Ciò che accomuna il nostro tempo a quel secolo è proprio la riscossa del privato e dell’individuale».
È grazie a questa consapevolezza che, dinanzi a un universo sovietico che s’inabissava dopo decenni di miserie quotidiane e brutali violenze poliziesche, egli saprà tirare ogni conseguenza da quel crollo rovinoso. E così, quando nel 1997 Marcello Veneziani si appellerà al Miglio del «Gruppo di Milano» per contestare le sue ultime prese di posizione, l’anziano senatore risponderà: «dall’83 a oggi è cambiato il mondo, a rendere superato quel tipo di proposta è stata la dissoluzione del sistema comunista: il collasso e poi lo schianto avvenuti a partire dal 1989, a mio parere, hanno posto in termini nuovi il problema dello Stato moderno». E sempre in quel dialogo trarrà ogni conseguenza da tale analisi, arrivando a sostenere che «l’età degli ‘Stati’ eterni e immutabili è per sempre finita». Se il federalismo è la grande e rinascente ossessione dello studioso lombardo, è ugualmente vero che esso viene letto e riproposto in costante connessione con un rinnovato interesse per il mercato, lo scambio, la libertà contrattuale. Ed è proprio nella libertà di stipulare accordi che può essere rinvenuto il vero punto di contatto tra la logica federale e l’economia liberale:
«Nello scorcio del XX secolo in cui stiamo vivendo, è arrivata a conclusione un’intera fase della storia dello Stato moderno, è in crisi l’idea che i cittadini debbano essere inquadrati una volta per tutte. Questa crisi si lega al declino del concetto di legge e al graduale emergere del primato del contratto, al quale deve far riscontro un sistema istituzionale nel quale prevalgano i patti liberamente negoziati, anzi: nel quale la legge nasca dal contratto».
Per tale ragione, quando Marcello Staglieno chiese a Miglio come egli pensasse di conciliare «questa vistosa concessione a prospettive non solo federaliste, ma addirittura ‘libertarie’, con la sua dottrina ‘decisionista’», la risposta fu molto netta: «Io non sono mai stato un ‘decisionista integrale’: voglio dire che mi sono sempre guardato bene dall’attribuire alla ‘decisione’ la portata trascendente, in chiave autoritaria, che sembrano attribuirgli Carl Schmitt o Hermann Heller». Per Miglio, insomma, evidenziare – contro Hans Kelsen – l’irriducibilità della dimensione politica non implica affatto una glorificazione dello Stato, della coercizione, della violenza ‘organizzata’. L’autore de Le regolarità della politica, d’altra parte, non crede affatto che «un sistema istituzionale, nel quale prevalgano i ‘contratti’ liberamente negoziati – anzi: nel quale la legge nasca dal contratto, e non da presunti valori mistici, ormai indifendibili – sia un sistema disordinato e altamente imprevedibile». Sono d’altra parte ormai numerosi gli studiosi, anche italiani (si pensi alle ricerche di Enrico di Robilant), che hanno evidenziato la superiore razionalità degli ordini dinamici, instabili, a potere diffuso, contro la rigida staticità degli apparati incapaci di correggersi ed evolvere. E queste indagini sono da tempo ben presenti a Miglio.
Oltre a ciò, egli comprende come il crollo degli idola che hanno segnato la modernità (nazione, razza, classe, democrazia, tecnica, ecc.) apra la strada a un’epoca nuova. La fortuna attuale della teoria federale è quindi strettamente legata al declino dell’obbligo politico e al fatto che l’età presente sta mostrando il progressivo secolarizzarsi di ogni vecchia teologia istituzionale, «mentre cadono a uno a uno tutti i miti, tutte le finzioni politiche e non politiche, e il gusto aspro della critica realistica raggiunge finalmente anche le moltitudini». Nella società che pare profilarsi all’orizzonte «tutto si baserà – soltanto e laicamente – sulla inviolabilità (materiale) della regola pacta sunt servanda: una decisione interpersonale la fonderà, e altre decisioni saranno il suo prodotto. Il sistema complessivo sarà molto più coordinato, automatico e prevedibile di quello offerto dal vecchio Stato sovrano ormai in disarmo».
È stata proprio questa centralità della decisione interpersonale a indurre Miglio a evidenziare ripetutamente il forte nesso che collega mercato e federalismo, superando anche quella dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato che già Bruno Leoni aveva contestato con coraggio e originalità. Se negli anni Settanta il politologo lombardo aveva visto nell’opposizione Stato-mercato una controversia che sembrava «destinata a durare fino alla fine dei tempi», il ben più radicale Miglio degli ultimi anni prefigura un universo entro il quale le artificiose barriere poste tra un universo e l’altro si dissolvano. La stessa analisi sociologica del potere e del suo radicarsi in relazioni originariamente non giuridiche (non istituzionalizzate, non iterate) contribuisce a far luce sulla realtà.
Pur così diverse nelle loro premesse teoriche, le tradizioni del realismo europeo continentale, del federalismo autentico e del libertarismo americano finiscono quindi per incontrarsi, inverandosi reciprocamente. L’analisi disincatata dei meccanismi della decisione e lo sguardo lucido dello scienziato di fronte alla «finzione» statuale (che non ha un’esistenza propria, ma vive solo in virtù di coloro che da esso traggono benefici) aprono la strada all’immaginazione di inedite forme di diritto, socialità, economia e politica. La consapevolezza del carattere storico ed eminentemente moderno delle istituzioni statali, successive alla crisi dell’ordine medievale, rafforza un’ipotesi teorica come quella migliana, tesa a scrutare l’universo di possibilità che potrà aprirsi di fronte agli uomini nel momento in cui il potere statale finirà per dissolversi: così come a fine anni Ottanta sono crollati, a seguito di un’imprevista implosione, i sistemi socialisti (le istituzioni più statuali che la modernità abbia saputo produrre).
Come pochi altri studiosi, Miglio ha compreso l’importanza di saper prestare attenzione – anche in una logica comparativa – a quelle esperienze culturali e istituzionali orientate al pluralismo che la storia moderna ha espresso, ma non ha saputo salvaguardare. Oltre che alle città anseatiche, egli non è parco di indicazioni sulla vicenda dell’Olanda, all’interno della quale «esisteva una pluralità di competenti che variava continuamente». Miglio comprende insomma che civiltà perdute e sconfitte (quella olandese fu spazzata via dall’esercito napoleonico) hanno ancora lezioni da trasmetterci e che soprattutto vi è qualcosa di assolutamente contingente – come ha evidenziato pure Hendrik Spruyt- nel successo del modello statuale «sovrano» che ha dominato gli ultimi secoli.
Il politologo sottolinea come la storia non sia soltanto in condizione di mostrarci il carattere effimero di apparati pubblici che rivendicano per sé l’eternità e che invece, come è ovvio, hanno avuto un inizio e conosceranno una fine: essa ci permette pure di comprendere che la dispersione concorrenziale del potere propria dei sistemi autenticamente federali rappresenta un forte ostacolo alla crescita indiscriminata dell’arbitrio statale, della tassazione e della regolamentazione. Le società politiche non centralizzate – dai liberi Comuni medievali alle Province Unite, dalle città anseatiche alla confederazione svizzera – erano indotte a privilegiare il mercato, la concorrenza, la competizione. Libertarismo e teoria neofederale, insomma, tendono sempre più a convergere.
Nella riflessione di Gianfranco Miglio, d’altra parte, il federalismo non è considerato uno strumento pensato per unire, ma una strategia volta a «tutelare e gestire le diversità». Esso cerca di favorire «il passaggio dall’unità alla pluralità: ex uno plures»; al punto che si può legittimamente sostenere che «sono federali quelle relazioni che dissolvono la concezione piramidale e gerarchica del potere, sostituendola con una dinamica delle relazioni di potere articolata in sfere concorrenti o esclusive dei poteri esercitabili». Questo spiega bene perché per Miglio il diritto di secessione sia «il diritto di stare con chi si vuole e con chi ci vuole» e perché tale diritto sia «simile a quello di resistenza, proprio perché naturale, inalienabile e indisponibile da parte del potere politico».
La cultura neofederalista punta così a realizzare «un ‘foedus’ condizionato, temporalmente limitato» ed è per questo motivo che agli occhi di Miglio il diritto di secessione «è un diritto prepolitico, che esiste, al pari del diritto di resistenza, come un prius rispetto a ogni comunità politica organizzata».
Come si è già rilevato, sullo sfondo di tali analisi migliane su un federalismo da contrattare e rinegoziare in continuazione c’è la teoria della doppia obbligazione (obbligo politico e obbligo-contratto): una concezione che, sebbene abbia un’origine del tutto autonoma, può offrire un solido contributo alla stessa dottrina libertaria. Tanto più che quella neofederalista è una concezione sostanzialmente pattizia delle relazioni politiche, che lascia spazio anche a federazioni a termine: rinnovabili solo se gli Stati federati trovano giusto e conveniente farlo. La politica perde insomma quei suoi tratti ossessivamente ancorati al concetto moderno della «sovranità», al punto che ogni finzione istituzionale si dissolve per svelare tutta la propria fragilità. La politica torna così a essere un fatto di uomini, più o meno disposti a collaborare pacificamente, a combattersi, a stipulare accordi e trattati.
Il tema del carattere necessariamente precario delle istituzioni umane spinge quindi l’anziano professore al recupero di una vecchia concezione jeffersoniana: quell’idea in virtù della quale ogni generazione deve avere la libertà di darsi una propria costituzione la cui durata sia ben definita. Qualche anno fa egli espresse con queste parole la ferma convinzione che «le comunità federali dell’ormai imminente ventunesimo secolo saranno tutte ‘temporalmente limitate’: cioè soggette a essere ‘revisionate’ ogni trenta-cinquant’anni. Il dogma teologico dell’immutabilità dello Stato, e della sacralità dei confini, poteva essere accettato in tempi in cui i fattori economico-sociali cambiavano molto lentamente, non certo ai giorni nostri. E la sfida di fronte al quale si troverà presto il diritto pubblico europeo sarà proprio quella di disegnare istituzioni flessibili dal punta di vista del fattore tempo».
Di fronte a un tale radicalismo anti-statalista non è certo casuale che negli ultimi anni siano stati proprio alcuni tra i più giovani allievi del professor Miglio ad attirare l’attenzione, all’interno della nostra vita culturale, su quelle ricerche che prefigurano un processo di superamento dello Stato moderno e si sforzano di valorizzare quanto vi è di autenticamente federale in talune tradizioni politico-istituzionali. Ci si riferisce, evidentemente, agli studi condotti da Martin Diamond e soprattutto da Daniel J. Elazar, il quale ha individuato nella teoria federale la possibilità di rigettare le concezioni tradizionali dello Stato: tanto quella gerarchica come quella organicistica.
In questa linea di pensiero neo-federalista all’interno della quale lo stesso Miglio ha voluto collocarsi, la federazione è quindi intesa quale accordo volontariamente pattuito: una relazione tra comunità che liberamente contrattano e in tal modo danno vita a un’istituzione perennemente bisognosa di definirsi e legittimarsi. In virtù del patto federale i rapporti tra i partecipanti della vita pubblica si istituzionalizzano, ma senza che venga meno la costante esigenza di ottenere conferma e consenso da parte dei soggetti contraenti il patto. Questa vocazione al dialogo e alla transazione segna la vita delle società federali anche al di fuori dell’ambito politico: «il federalismo implica un atteggiamento e un modo di comportarsi nelle relazioni sociali, oltre che politiche, che porta a interazioni umane fondate sulla cooperazione negoziata, sulla condivisione fra le parti e sul coordinamento, piuttosto che sulla relazione gerarchica tra superiore e subordinato». La parità tra gli attori istituzionali che caratterizza i modelli a matrice (senza gerarchia) è allora essenziale perché ci si trovi di fronte a un ordine veramente federale e, quindi, rispettoso dei diritti delle comunità.
Per il federalismo libertario dell’ultimo Miglio, ogni potere legittimo è sempre e solo un potere delegato. Entrando in società, gli uomini non cedono la propria libertà, non si assoggettano a un tiranno né si riducono volontariamente in condizione di schiavitù, ma semplicemente attribuiscono a un’istituzione nuova una parte dei loro poteri e accettano una serie di regole.
Ma essi restano sempre pronti a discutere tali norme, a contestarle, a fondarne di nuove. Gli uomini elaborano regole per difendere i loro diritti e, per questa ragione, continuano a essere gli ultimi e più importanti tutori di tali fondamentali prerogative, essenzialmente «pre-politiche».



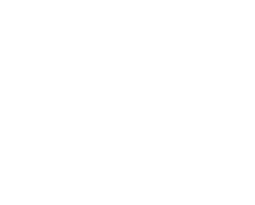
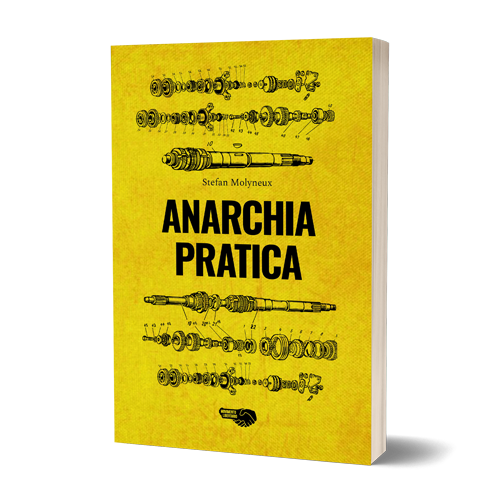

Al di là delle beghe tra pensatori intelligenti e uomini-immagine invidiosi e cialtroni, la lezione da tenere presente, a livello di principio, che in parecchi non hanno mai appreso è: spersonalizzare, astrarre, misticizzare nel tentativo di costruire idoli per le masse nell’eterna ricerca dell’ordine porta solo a maggior casino.
Non ho mai capito il perchè bossi abbia emarginato e poi criticato il Prof.Miglio ,dopo averne sfruttato l’intelligenza e la preparazione.
Quanto suggeriva Miglio era l’unica efficiente soluzione federalista che la lega avrebbe dovuto perseguire.
Non è certo stata lungimiranza quella di bossi nel maltrattare Miglio.
Forse neppure astuzia.
E’ stata la prova della sua incapacità personale ad elaborare le richieste dei “padani” , che ha ingannato con costanti e metodiche marce indietro sulle richieste “federaliste.
Fino ad accontentarsi,lui, e a lasciar imporre ai cittadini quella porcheria di riforma federalista che va sbandierando ad ogni piè sospinto.
Un Miglio più giovane di 15 anni avrebbe potuto far la differenza.
Perchè Miglio gli faceva ombra, piaceva più Miglio alla base che Bossi. Cosa insopportabile per il cialtrone. Tutto spiegato in UMBERTO MAGNO!